.
 Il verso probabilmente più noto della Divina Commedia ha forse dato vita ad uno dei più tenaci equivoci della Storia della Letteratura, se è vero che esso dura da più di sette secoli: l’amore che assicura a chi ama di essere riamato! Come poteva il genio di Dante esprimere una così sciocca sentenza? Non convincono certo i riferimenti al trattato di Andrea Cappellano, che dovrebbero suffragare l’esegesi tradizionale: Dante ha scritto, a nostro avviso, un aforisma che non è mai stato capito! Proviamo a dimostrarlo… provando contemporaneamente che il Saggio “O Dante o Benigni” sa anche essere propositivo.
Il verso probabilmente più noto della Divina Commedia ha forse dato vita ad uno dei più tenaci equivoci della Storia della Letteratura, se è vero che esso dura da più di sette secoli: l’amore che assicura a chi ama di essere riamato! Come poteva il genio di Dante esprimere una così sciocca sentenza? Non convincono certo i riferimenti al trattato di Andrea Cappellano, che dovrebbero suffragare l’esegesi tradizionale: Dante ha scritto, a nostro avviso, un aforisma che non è mai stato capito! Proviamo a dimostrarlo… provando contemporaneamente che il Saggio “O Dante o Benigni” sa anche essere propositivo.
Questo post è stato visibilmente plagiato in una pagina della Rete,
da tal Guglielmo Peralta, come ho evidenziato, ripubblicandolo, al link
www.odanteobenigni.it/amor-cha-nullo-amato-una-rivoluzionaria-esegesi-con-plagio/
_________________________
AMOR NIL POSSET AMORI DENEGARE
Amor, ch’a nullo amato amar perdona…
Il nostro primo dubbio sull’interpretazione del verso Amor, ch’a nullo amato amar perdona risale alla seconda metà degli anni Sessanta. Leggevamo la Storia della Letteratura Italiana di Arturo Pompeati (UTET, 1965) e il rapido, lapidario commento del critico, riferito all’aforisma dantesco: “Eresia psicologica che è poi invece il dogma degli amori corrisposti” ci provocò un immediato senso di ribellione! In che modo un genio come Dante era potuto incorrere in un abbaglio del genere? Qualunque essere umano, di qualunque estrazione mentale, sa che non basta amare per essere riamati: magari fosse così! Nessun amante sarebbe mai respinto e non esisterebbero delusioni d’amore. Il pensiero di Dante non poteva essere quello. C’era però tutta la tradizione ermeneutica a supporto dell’affermazione del Pompeati, che bollava il verso come “eretico” attenuando appena la condanna in riferimento al caso specifico. E c’era il Gualtieri [1] del Cappellano! Non avevamo risorse, allora.
Per lustri il dilemma fu un sedimento, un tarlo di cui avvertivamo talvolta il rodere sommesso, un seme sulla pietra… Non sapremmo per quale battito di vento quel seme sia scivolato sul terreno per germogliare…
La lingua non ha le caratteristiche della matematica, è per sua natura ambigua, polisemica, non solo per la pluralità dei significati che un vocabolario attribuisce a molti dei singoli lemmi, quanto, se non soprattutto, per la varietà di senso cui danno luogo le associazioni delle parole. [2] Non a caso, le moderne esigenze dell’informatica hanno portato al moltiplicarsi delle ricerche per la messa a punto dei programmi di gestione del testo linguistico, in relazione ai problemi generati dall’ambiguità semantica.
La premessa è breve, ma è sufficiente, in questo contesto, per gli scopi che ci prefiggiamo, anche se non si impedisce a nessuno di approfondire l’argomento.
L’interpretazione tradizionale del verso di cui ci occupiamo, si è sempre appoggiata alla teorica dell’amor cortese, in particolar modo al trattato di Andrea Cappellano, rimanendo rigidamente imprigionata in un certo tipo di lettura del Gualtieri, cui sacrificava perfino l’intelligenza dell’Alighieri.
Bruno Gentili, a proposito, molto recentemente ha sostenuto: «Questa norma di reciprocità e reversibilità sarà un principio cardine dell’amore cortese del XII secolo [3] e varrà nelle teorie degli scrittori religiosi medioevali come argomento per dimostrare la necessità di amare Dio con l’amore che Dio nutre per tutti gli uomini; [4] diverrà poi in Dante il simbolo del tragico amore di Francesca: “Amor, ch’a nullo amato amar perdona”, amore che non consente che chi è amato non riami». [5]
Per come si presenta, l’opera di Andrea Cappellano “fu solennemente condannata dal vescovo di Parigi, Etienne Tempier, il 7 marzo 1277, [6] malgrado lo stesso autore avesse in qualche modo bilanciato l’arditezza delle sue tesi nel terzo libro del trattato, significativamente intitolato De reprobatione amoris, che offre una sorta di palinodia di quanto veniva sostenuto nei due libri precedenti”; [7] per questo essa non sembra conciliabile con l’ortodossia che anima la Commedia. La cosa avrebbe dovuto indurre a una riflessione più accurata. Gianfranco Contini, a dire il vero, sostiene che «Dante conosceva Gualtieri e per quanto egli avvolga quel nome nel manto della più totale preterizione e, certo, disistima», l’opera è puntualmente dietro il discorso di Francesca, e per essa di Dante”. [8] Si può anche essere d’accordo, purché si precisi che Dante, ponendo sulle labbra e nel cuore di Francesca il pensiero del Cappellano, altro non sceglie che sottolineare la colpa della peccatrice, [9] se è vero che il De amore era stato condannato proprio per la sua concezione contraria alla morale cristiana. [10] Vogliamo dire che, per il suo carattere “trasgressivo”, il trattato del Cappellano ben si prestava a giustificare il perseverante peccato dei due dannati. È innegabile, infatti, l’appellarsi di Francesca alla forza irresistibile dell’amore senza alcun accenno al pentimento, che cerchi discolpa o comprensione, oppure entrambe. È altrettanto evidente che, se Dante avesse fino in fondo legittimato il peccato di Francesca attraverso il Gualtieri, non avrebbe collocato i due cognati adulteri all’Inferno. Il suo “pietoso” ascolto non può essere quindi indulgente: la sua è sempre, sarà sempre, un’umana comprensione, mai un avallo, in un tragitto di redenzione proteso all’affrancamento dagli affetti umani verso l’amor che move il sole e l’altre stelle. E se la carnalità è passione di cui l’Alighieri conosce la prepotenza, la vertigine, addirittura, sia pure nella “pietà” (e caddi come corpo morto cade), egli “cadrebbe” davvero in un’insanabile, incomprensibile contraddizione se volessimo artificiosamente attribuirgli complicità nei confronti di Francesca da Rimini e di Paolo Malatesta, o trasformare, come fa lo sprovveduto Roberto Benigni, il V Canto dell’Inferno, da esempio di condanna ad apoteosi dell’amore, non solo dei sensi.
Noi crediamo che un’analisi più indipendente e la maggiore flessibilità conseguente, avrebbero potuto aprire alla critica sbocchi diversi. Non condizionati dalla precedente letteratura sull’argomento, o da questa spinti alla “difesa” di Dante, non siamo mai riusciti ad accettare l’esegesi universalmente condivisa.
Commentando il verso che analizziamo, Natalino Sapegno sostiene: “La tesi è esposta nel De amore di Andrea Cappellano (De amore, II 8, reg. 26); ed era vera anche per gli scrittori religiosi, come argomento per dimostrare la necessità di amare Dio; così Fra Giordano da Pisa: ‘Non è nullo che, sentendosi che sia amato da alcuno, ch’egli non sia tratto ad amar lui incontanente’; e Santa Caterina: ‘naturalmente l’anima è tratta ad amare quello da cui sé vede essere amata’” (Natalino Sapegno, La Divina Commedia, Inferno).  Approfondiamo allora le citazioni alle quali il critico si riferisce.
Approfondiamo allora le citazioni alle quali il critico si riferisce.
1) Amor nil posset amori denegare: l’amore non può negare nulla all’amore.
“Il volgarizzamento” fiorentino, conosciuto come traduzione romana per la sede in cui è custodito (la Vaticana), traduce: l’amante lievemente non può distorre a l’altro nulla… Già sorge il dubbio: vorrà davvero il Cappellano significare quello che Dante dovrebbe ripetere e che a nostro parere nessuno dei due proprio dichiara? Per di più la proposizione ha una struttura che richiama il principio di non contraddizione: l’amore non può negare se stesso, non può essere non-amore.
2) Non è nullo che, sentendosi che sia amato da alcuno, ch’egli non sia tratto ad amar lui incontanente (Fra Giordano da Pisa); naturalmente l’anima è tratta ad amare quello da cui sé vede essere amata (Santa Caterina).
3) Aggiungiamo noi, attraverso il già citato Santagata: “Francesca è più realista del re: nell’indicare la bellezza come causa dell’amore nato fra lei e Paolo, senza saperlo, lei, che ha velleità di donna colta, colloca se stessa, stando proprio al Cappellano, fra i “semplici”, gli “indotti”:
formae venustas modico labore sibi quaerit amorem, maxime si amorem simplicis requirit amantis. Simplex enim amans nil credit aliud in amante quaerendum nisi formam faciemque venustatem et corporis cultum [la bellezza si procura l’amore con poca fatica, soprattutto se aspira all’amore di un innamorato "ingenuo". L’innamorato ingenuo, infatti, crede che nell’amata non si debba cercare che la bellezza, la piacevolezza, la leggiadria, l’aspetto curato].
Opposto è il comportamento del “savio”, del “doctus”:
morum probitas acquirit amorem in morum probitate fulgentem. Doctus enim amans vel docta deformem non reiicit amantem, si moribus intus abundet (I x, 18) [la virtù d’animo cerca un amore che risplenda della virtù d’animo: l’innamorato savio, o l’innamorata, infatti, non respinge un amato brutto, se dentro è ricco di virtù].
Insomma, Francesca è colta e informata, almeno quanto è superficiale e semplificatrice”.
Perché Dante avrebbe scelto per Francesca di ritenere l’attrazione fisica quale “prima radice” dell’amore colpevole (prese costui de la bella persona), quando nel Cappellano si considera chiaramente anche l’amore verso cui tende la virtù d’animo? Evidentemente per rimarcare la condizione di peccatrice dannata dell’amante di Paolo. Non è quindi nemmeno necessario pensare, come Marco Santagata, che “Dante affidi ai discorsi e ai comportamenti di una donna come questa il compito di esemplificare le colpe etiche e culturali della civiltà cortese o quanto meno della sua letteratura…” o, più correttamente, “che Dante, attraverso Francesca, intenda esemplificare un modo distorto di leggere quei testi, che la sua, cioè, non sia una critica all’ideologia dell’amore cortese, ma alla ricezione che certi ambienti sociali al suo tempo ne facevano” .
Infatti il Cappellano è ben attento a lasciare “alla persona amata la libertà di non riamare chi lo (o la) ama” [11]
Ideo ergo amor in arbitrio posuit amantis, ut, quum amatur, et ipsa, si velit, amet, si vero nolit, non cogatur amare (I, 44) [Dunque amore ha lasciato facoltà a colei che ama, quando è amata, di amare a sua volta, se vuole, e di non essere costretta ad amare, se invece non vuole];
Vere profiteor in mulieris esse collatum arbitrium postulanti, si velit, amorem concedere, et, si non concedat, nullam videtur iniuriam facere (I, 104) [Affermo che alla donna è stata attribuita facoltà, se vuole, di concedere il suo amore a chi la ama, e, se non lo concede, non si ritiene che commetta un torto].
“La sofisticazione della dottrina di Andrea – commenta Avalle – non poteva essere più disinvolta, soprattutto laddove si fa esplicito riferimento all’‘arbitrio’ della persona amata (nella fattispecie della donna)”. Ne conclude che di quel dialogo Francesca è “cattiva o interessata lettrice”.
A noi interessa in modo particolare proprio la facoltà di assenso che il Cappellano riserva alla donna amata e che sarebbe in forte contraddizione con le regole che i critici adducono a sostegno dell’interpretazione del passo dantesco. Perché a nostro avviso è possibile dimostrare che tale contraddizione non c’è!
Abbiamo raggruppato nel punto 2 le due citazioni degli scrittori religiosi perché esse appartengono ad una stessa categoria e perché – non escludiamo il passo del De amore cui poc’anzi si accennava (la virtù d’animo cerca un amore che risplenda della virtù d’animo) - trovano proprio nella Divina Commedia, ma non nel V dell’Inferno, un’eco incontestabile (già rilevata dal Boccaccio nel suo Comento alla Divina Commedia, Lez. VIII):
… “Amore, / acceso di virtù, sempre altro accese…” (Purgatorio, XXII, vv. 10-11)
In tutti e tre i passi su citati l’amore di cui si parla è “virtuoso”, inoppugnabilmente: e non è la passione che unisce Paolo e Francesca.
Perché Dante ha bisogno di precisare “acceso di virtù”? O forse questa non è una puntualizzazione, sicché l’Alighieri considererebbe virtuoso anche l’amore dei lussuriosi del II Cerchio infernale? Un’ipotesi quantomeno ardua da sostenere. Il nostro precedente dubbio diventa più forte.
C’è di più: quando Francesco da Buti (1324-1406) sostiene che l’amore “carnale non accende sempre, imperò che non accende se non li carnali; ma l’amore virtuoso sempre accende li virtuosi”, nemmeno può essere citato per suffragare l’ipotesi che “l’amore non perdona a nessun amato di riamare”, perché quanto meno esso “perdona” al virtuoso di riamare il colpevole! Dunque la massima dantesca non conterrebbe il caso dell’amore colpevole che ama il virtuoso, dal quale evidentemente non può essere ricambiato!
La questione diventa più complessa, ma anche più affascinante. Forse è il caso di tornare al testo del Cappellano, a quello che per i critici sembra essere stato il più condizionante.
Amor nil posset amori denegare
Intanto il congiuntivo posset non rende la regola del Cappellano apodittica… In secondo luogo l’asserzione non è affatto univoca e contiene in sé, al di fuori quindi del contesto riferito a Dante e al Cappellano stesso, almeno cinque significati, non considerando la “variabile di conoscenza”, che analizzeremo successivamente:
- L’amore niente potrebbe negare all’amore: principio di non contraddizione: A non è NON-A;
- L’amore niente potrebbe negare “a se stesso”, niente potrebbe negarsi, tutto permettersi;
- L’amore possibile di X per Y niente potrebbe negare (anche se X ancora non ama Y) all’amore nutrito da Y per X: il caso dell’interpretazione tradizionale.
- L’amore che X nutre per Y niente potrebbe negare all’amore ricevuto da Y: l’amore di X concederebbe tutto a Y che ricambia.
- L’amore che X nutre per Y niente potrebbe negare all’amore possibile di Y per X: niente X negherebbe a Y, che questi ricambi o meno.
Consideriamo adesso tutti i casi possibili inserendo la “variabile di conoscenza”, dal momento che la domanda che Dante rivolge a Francesca indica che i due cognati non erano a conoscenza del loro sentimento fino al giorno della lettura fatale:
A che e come concedette amore / che conosceste i dubbiosi disiri?
X = Francesca; Y = Paolo; A = Amore
1 A non è non-A
2 A non nega nulla ad A, tutto concede a se stesso
3 X non ama Y che non lo sa; Y ama X che non lo sa (premessa favorevole all’interpretazione tradizionale):
X amerà necessariamente Y: è il caso di “Amor, ch’a nullo amato amar perdona” secondo la tradizione, visto che mi prese del costui piacer sì forte indicherebbe che Francesca si sarebbe innamorata come conseguenza dell’amore di Paolo, non essendole possibile sottrarsi per la forza stessa dell’amore! Perciò X che non amava Y, nel momento in cui si rende conto che Y l’ama, è costretto a ricambiare!
X non ama Y che non lo sa; Y ama X che lo sa (non è il caso del passo Dantesco)
X non ama Y che lo sa; Y ama X che non lo sa (non è il caso del passo Dantesco)
X non ama Y che lo sa; Y ama X che lo sa (non è il caso del passo Dantesco)
4 X ama Y e Y non lo sa; Y ama X che non lo sa: è la premessa per l’avverarsi della nostra interpretazione
X ama Y e Y non lo sa; Y ama X che lo sa (non è il caso del passo Dantesco)
X ama Y e Y lo sa ; Y ama X che non lo sa (non è il caso del passo Dantesco)
X ama Y e Y lo sa; Y ama X che lo sa:
uuuuuuuuuuè la combinazione dell’avverarsi della nostra interpretazione.
5 X ama Y e Y non lo sa; Y non ama X che non lo sa
uuuuuuuX ama Y e Y non lo sa; Y non ama X che lo sa
uuuuuuuX ama Y e Y lo sa; Y non ama X che non lo sa
uuuuuuuX ama Y e Y lo sa; Y non ama X che lo sa
Le quattro combinazioni del punto 5 riguardano il caso in cui è Paolo che non sa (la prima combinazione contiene la premessa per cui egli “sarebbe costretto” ad amare Francesca una volta venuto a conoscenza dell’amore di lei, secondo l’interpretazione tradizionale), ma non le analizziamo in dettaglio perché non si conciliano con il racconto dantesco.
6 X non ama Y; Y non ama X: questa combinazione e quelle da essa derivanti, non interessano ai fini della nostra dimostrazione.
La condizione che avalla l’interpretazione da noi scelta è quindi: X ama Y e Y lo sa; Y ama X e X lo sa
Vediamo come:
X ama Y e Y non lo sa; Y ama X e X non lo sa
Francesca ama Paolo e Paolo non lo sa; Paolo ama Francesca e Francesca non lo sa –
ma…
per più fiate gli occhi ci sospinse
quella lettura e scolorocci in viso – a questo punto
X ama Y e Y lo sa; Y ama X e X lo sa
Francesca ama Paolo e Paolo lo sa; Paolo ama Francesca e Francesca lo sa
dunque
| l’amore nutrito (amor) che a nessuno ricambiato (ch’a nullo amato) dà scampo (amar perdona) |
mi prese del costui piacer sì forte… divampò senza controllo.
Prima di trarre le conclusioni estendiamo l’analisi ad un’altra regola alla quale i critici si appellano per la loro dimostrazione:
Amare nemo potest, nisi qui amoris suasione compellitur
Nessuno può amare se non costretto dalla potenza dell’amore (è la traduzione più ricorrente).
Non ci pare che questa “regola” dica qualcosa di nuovo o di straordinario per avvalorare in maniera decisiva l’interpretazione del verso 103 del Canto di Francesca secondo la formula ormai consolidatasi. Anche in questo caso si manifesta una pluralità di significati, sia pure molto più limitata.
Amoris è genitivo soggettivo oppure oggettivo? Significa dell’amore o per l’amore?
- Nessuno può amare se non chi è conquistato all’amore dal fatto di essere amato? (genitivo oggettivo) oppure
- Nessuno può amare se non chi è spinto a farlo dalla forza dell’istinto naturale? (genitivo soggettivo) o ancora
- Nessuno può amare se non chi è costretto dalla spinta dell’amore (astrattamente)? (genitivo soggettivo)
- Oppure, addirittura: al cuor non si comanda? (Se mai, quindi, il motivo per cui Francesca non poté amare Gianciotto).
Senza volerci atteggiare a latinisti, la nostra sensibilità ci fa sentire in suasione la “suasio”, appunto, non la “vis”, di modo che nel “suasione compellitur” avvertiamo più un sospingere che un costringere, pur dovendo ammettere che il compellitur allude a un impulso irrefrenabile. Il volgarizzamento però traduce: Niuno può amare se non quello ov’è il suo cuore e l’irrefrenabilità può essere allora intesa come spinta incoercibile verso l’oggetto d’amore prescelto. La regola vorrebbe dunque semplicemente significare che nessuno può amare se non l’oggetto d’amore verso cui è orientato irrimediabilmente il suo cuore e, in modo sottinteso, forse, che nessuno può spingere chicchessia ad amare un oggetto d’amore diverso da quello che questi ha prescelto! Da qui ad affermare che, quando si ama, certamente si sarà ricambiati, il passo è ben lungo.
Adattando al verso dantesco il significato della regola del Cappellano che, fra quelli possibili, ci è sembrato il più congeniale, capace di dare maggiore coerenza allo stesso pensiero del De Amore, [12] ne conseguirebbe, come si è visto, che Dante non si contraddice con quanto afferma nel Purgatorio (XXII, vv. 10-1), ma soprattutto che non cade nell’”eresia psicologica” rimproveratagli dal Pompeati (e non solo): l’amore di X per Y non permette a nessun X di sottrarsi all’avveramento della relazione amorosa nell’evenienza in cui Y sveli il suo amore a X; l’amore (che quindi deve già essere nutrito) come sentimento, non come forza astratta, o addirittura come divinità, non permette a nessuno, che lo nutra, di sottrarsi all’oggetto d’amore che si dimostra a sua volta innamorato. Se è necessario un così contorto ragionamento per dare chiarezza al significato del verso, è pur vero che una volta acquisita la comprensione, il senso del verso medesimo diventa intuitivo: l’amore nutrito (Amor) che a nessuno che sia corrisposto (ch’a nullo amato) dà scampo (amar perdona).
Tralasciamo a questo punto le X e le Y e riferiamoci a Paolo e Francesca, riepilogando il senso completo delle più famose terzine del V Canto dell’Inferno.
Il sentimento d’amore che rapidamente si accende nell’animo nobile, ad esso naturalmente disposto, innamorò Paolo dell’avvenente aspetto che mi fu strappato con la violenza da Gianciotto, e della natura di quell’amore “proibito” ancora subisco le conseguenze (in tutti i sensi). L’amore nutrito nei confronti di Paolo, che non mi ha permesso, come non permette a nessuno in condizioni analoghe, di eludere chi a sua volta si dimostrava innamorato di me, mi divampò dentro, mi prese [13] in maniera così forte, che, come puoi ben constatare, perdura. Sicché fummo condannati da una stessa passione ad una stessa morte (sia fisica che spirituale [14]): ma chi ci ha tolto la vita finirà fra i traditori dei parenti, nel fondo dell’Inferno (Caina)!
Non abbiamo la pretesa di aver detto la parola definitiva a riguardo, ma godiamo della soddisfazione di essere pervenuti a un senso che non espone Dante alla critica di aver preso un abbaglio così clamoroso (non c’è giustificazione che potrebbe perdonarlo: nessuno mai avrebbe potuto sostenere un principio tanto assurdo come quello che vuole un “amato” costretto a corrispondere, tanto meno un genio come l’Alighieri).
A titolo di curiosità riportiamo anche una prima idea, quella che ha mosso la ricerca successiva, da noi in seguito scartata perché poco lineare e scarsamente eufonica nella lettura alla quale costringeva, ma che comunque può giovarsi di tutte le argomentazioni che abbiamo addotte.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona
Amor che a nullo (a nessuno, considerato come pronome) perdona amar (permette di non amare) amato (la persona scelta come oggetto d’amore; “amato” va qui considerato con funzione logica di complemento oggetto).
Non c’è forza che permetta di sottrarsi all’amore per la persona che si ama (amato), verso la quale si prova cioè trasporto amoroso.
L’uso di nullo come pronome si ritrova in Dante altre due volte (se non abbiamo commesso errori nel controllo):
Inferno, Canto XXXI, verso 81
come ‘l suo ad altrui, ch’a nullo è noto
Paradiso, Canto XXIV, verso 21
che nullo vi lasciò di più chiarezza
Consulta in fondo alla scheda il parere di Giorgio Bàrberi Squarotti
___________________________
L’esegesi è tratta dal Saggio O Dante o Benigni, di Amato Maria Bernabei, Arduino Sacco Editore, Roma 2011, pp. 283-295
[1] http://www.classicitaliani.it/index124.htm
[2] Qual è il senso dell’espressione “gli acidi grassi”? Quello di acidi monocarbossilici alifatici, ingredienti costitutivi di quasi tutti i lipidi complessi e dei grassi vegetali e animali, oppure semplicemente di grassoni astiosi e malevoli? “Il primo atto del barbiere” è l’insaponatura o la prima parte dell’opera di Rossini? “I testi sono portatori di ambiguità, di carattere semantico e sintattico”… “Non è forse superfluo ricordare ancora una volta che i significati connotativi sono estremamente instabili, e che i significati denotativi di una parola in un codice naturale differiscono sempre da quelli di qualsiasi altra parola, sia appartenente al medesimo codice naturale, sia appartenente a un altro codice naturale”.
http://courses.logos.it/IT/2_10.html
[3] A. Cappellano, Trattato d’amore, testo latino del XII secolo con due traduzioni toscane inedite del secolo XIV, a cura di S. Battaglia, Roma 1947, regola IX: “Amare nemo potest nisi qui amoris suasione compellitur”; regola XXVI: “Amor nil posset amori denegare”; cfr. Contini 1976, p. 46 e soprattutto Avalle 1977, pp. 39 sgg.
[4] Fra Giordano da Pisa: ‘Non è nullo che, sentendosi che sia amato da alcuno, ch’egli non sia tratto ad amar lui incontanente’; Santa Caterina: ‘naturalmente l’anima è tratta ad amare quello da cui sé vede essere amata’. Cfr. Avalle 1977, p. 41.
[5] (Bruno Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Universale Economica Feltrinelli, Milano 2006, p. 152).
[6] Cfr. A.J. Denomy, The “De amore” of Andreas Capellanus and the Condemnation of 1277, in Mediaeval Studies, 1946, vol. VIII, pp. 107-49.
[7] http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/leggereDante/V_Inf_Malato.pdf.
[8] www.indire.it/leggeredante/upl/enrico_malato/La%20dottrina%20medievale%20dell’amor%20cortese.doc
[9] “Non vale quasi la pena di rilevare la profonda dissimiglianza fra ciò che Francesca pensa dell’amore e il “tono” della canzone guinizzelliana da lei addotta come auctoritas: è evidente che Francesca esprime convinzioni sue e intreccia sue parentele culturali che Dante non avrebbe facilmente accettato. Dante come avrebbe potuto appiattire il “padre” suo e “de li altri… che mai / rime d’amor usar dolci e leggiadre” (Purg. XXVI 97-99) su una concezione puramente fisica e materialistica dell’amore?” (Marco Santagata).
http://www.italica.rai.it/principali/dante/santagata/capitoli/f_10.htm
[10] “Il Cappellano espone, in effetti, un’idea materialista dell’amore, basato sul desiderio fisico e teso al suo soddisfacimento” (Marco Santagata, nel sito citato).
[11] Avalle, D’Arco Silvio. “Prolegomeni all’innominata” In: Istituto Universitario Orientale, Napoli. Beatrice nell’opera di Dante e nella memoria europea 120-1990. Atti del Convegno Internazionale 10-14 dicembre 1990, a c. di Maria Picchio Simonelli. Firenze, Cadmo 1994, 29.
[12] Cfr. la combinazione sopra analizzata “X ama Y e Y lo sa; Y ama X e X lo sa” e le interpretazioni date del testo del Cappellano.
[13] In quest’ottica del costui piacer diventa “per il fatto di essere corrisposta, perché anch’io gli piacevo”. Il Caretti aveva già proposto “amore” come significato di piacer, osservando che: «Il parallelismo delle due terzine non si attua attraverso la bellezza della donna e quella dell’uomo […], bensì attraverso l’identica irresistibile forza onde son mossi i due affetti».
http://2rosati.blogspot.com/2010/08/1.html
[14] La “seconda morte” cui Dante allude nel I Canto dell’Inferno (verso 117). Vale la pena di far notare che nel commentare il verso appena ricordato, con la consueta superficialità, frutto della sua frettolosa preparazione, Benigni riferisce l’interpretazione meno attendibile (per cui la seconda morte sarebbe quella successiva al Giudizio Universale: seconda morte) non alludendo nemmeno a quella più probabile, fondata sui testi danteschi e sulla tradizione. Vos autem divina iura et humana transgredientes, quos dira cupiditatis ingluvies paratos in omne nefas illexit, nonne terror secunde mortis exagitat…? (secondo il testo curato da Ermenegildo Pistelli per l’edizione della Società Dantesca Italiana, 1921): “Voi, poi, trasgressori delle leggi divine e di quelle umane, che le funeste fauci della cupidigia lusingarono ad apprestarvi ad ogni iniquità, non vi perseguita il terrore della dannazione…?” (Epistole, VI, 5, Dante, Tutte le opere, Newton Compton, Roma, 1993, p. 1165; cfr. pure “ka la morte secunda no ‘l farrà male”, San Francesco, Il Cantico di Frate Sole, 31). Per quanto riguarda l’affermazione che i dannati aspettano la seconda morte “sperando di stare un pochino meglio”, è evidente che Benigni non si ricorda del dialogo fra Dante e Virgilio nel VI Canto dell’Inferno, ai versi 103-108 (e che lui stesso “spiega”, come è possibile ascoltare dal documento sonoro staranno peggio tratto dalla serata del VI Canto, nel quale è stato operato il taglio – farraginoso e inutile ai nostri fini – di una breve digressione; senza tener conto che nel documento riportato Benigni prima afferma che la Summa Theologica è… Dio, poi allude non alla creatura più perfetta, ma alla “pena più perfetta”!): … «Maestro, esti tormenti / crescerann’ ei dopo la gran sentenza, / o fier minori, o saran sì cocenti?». / Ed elli a me: «Ritorna a tua scïenza, / che vuol, quanto la cosa è più perfetta, / più senta il bene, e così la doglienza.
* * * * * * *
IL PARERE DI GIORGIO BÀRBERI SQUAROTTI
Torino, 24 gennaio 2012
Caro Bernabei,
Le sono grato dell’invio della Sua geniale e documentata interpretazione della celebre terzina dantesca del potere dell’amore secondo Francesca. Mi piacerebbe discutere con Lei della questione, perché qualche dubbio in me rimane.
[...] Le propongo qualche ulteriore aspetto del testo, premettendo che le osservazioni di Santagata non mi convincono, in genere, in confronto con le proposte di Edoardo Sanguineti e di Angelo Iacomuzzi. A parlare è un’anima dannata che cerca di spiegare a Dante il suo errore mortale che l’ha portata all’inferno. Non si tratta soltanto delle citazioni vere dei canoni mondani dell’amore con cui Francesca vuole “giustificarsi”, scaricando su di loro la responsabilità del peccato, ma della confusione che Francesca fa fra l’amore terreno e fisico e l’Amore che move il sole e l’altre stelle. Come dice Bonaggiunta, le “nuove” rime (dei due Guidi, di Guinizelli in specie per il rimatore lucchese) guardano alla filosofia e all’idea dell’amore al tempo stesso divino e cortese, e non più alla naturalità sola del poetare che non può essere se non dell’amore di uomo e donna, come dice Dante stesso nel venticinquesimo capitolo della Vita nova. Nell’episodio della Commedia c’è l’eco della concezione dell’amore secondo la filosofia che Guido Cavalcanti espone e da cui Dante si distacca proprio nella Commedia. L’episodio dell’Inferno io credo che debba essere letto in questa prospettiva. Di qui, secondo me, l’ambiguità dell’orazione di Francesca.
Auguri per il volume dantesco! Con i più vivi saluti,
UN DOTTO CONTRIBUTO
UN VERSO DIVERSO?
Amor, ch’a nullo amato amar perdona
(“Inferno”, V, 103)
La tradizione secolare ha sempre interpretato questo celeberrimo verso in una sola maniera. E se Dante avesse invece inteso altro? L’innovativa teoria del prof. Bernabei (cfr. BERNABEI A. M., O Dante o Benigni – da Boccaccio a boccaccia, Roma, Arduino Sacco Editore, 2011) va arricchita con ulteriori riflessioni.
La concordanza morfologica tra nullo e amato e la lettura metrica come endecasillabo a maiore (ovvero con accento ritmico sulla sesta sillaba), ponendo una pausa frasale tra amato e amar, hanno certamente influito sulla spiegazione del verso. La sua sintassi senza inversioni retoriche suonerebbe così: Amor perdona amar a nullo amato; ovvero, in parafrasi: “Amore non risparmia a nessun amato di amare”. In altre parole, Dante starebbe suggerendo al lettore che una persona amata non possa non ricambiare il sentimento. Si tratterebbe del cosiddetto principio di “reciprocità”.
Eppure, almeno due considerazioni generano ripensamenti su questa spiegazione: una visione dell’amore piuttosto irrealistica; in quanto irrealistica, eccessivamente banale in Dante.
§ 1 Che l’amore debba essere ricambiato è fin troppo una palese assurdità, e Dante lo aveva sperimentato in prima persona: l’amata Bice Portinari aveva infatti sposato tale Simone de’ Bardi. Secondo il racconto della “Vita nova”, Dante aveva scritto le prime poesie per Beatrice lì confluite già in giovane età (quindi prima del matrimonio di lei), ma il suo amore appunto non era stato corrisposto, se non nel senso trobadorico di un corteggiamento puramente artistico.
È sufficiente questo a giustificare la tradizionale lettura del verso in questione? Consideriamo la cornice. Siamo nel canto V dell’“Inferno”, nel secondo cerchio, quello dei lussuriosi. Nell’antinferno Dante ha incontrato gli ignavi, né beati né condannati, seppur costretti alla terribile pena della corsa e delle punture di insetto; nel primo cerchio del limbo ha conosciuto gli spiriti magni, la cui punizione è puramente psicologica (il desiderio inappagabile di vedere Dio). I lussuriosi, invece, appartengono a una categoria maledetta da Dio, destinati alla bufera infernale che non si arresta mai. È evidentissimo il contrappasso per analogia: la violenza del turbine rappresenta la passione amorosa.
Il canto V dell’“Inferno” va considerato come l’esito concettualmente più impegnato tra i primi canti della “Comedìa”, anzi come il punto di arrivo di una riflessione secolare sulla fin’amor. Ribadiamo alcuni aspetti peculiari dell’amor cortese. Il poeta ama la donna senza possibilità di ricompensa carnale, perché lei è etimologicamente la sua signora, ovvero la castellana, già sposata col signore feudale, e per questo socialmente superiore all’amante. Tra i due si configura la metafora dell’impari rapporto vassallatico: servizio da parte del poeta amante e beneficio (non sessuale) da parte della donna amata. Esistono comunque le eccezioni a quest’ultima regola: la più famosa è quella di Ginevra e Lancillotto alla corte di re Artù.
Per Dante, poeta soprattutto d’amore ma turbato da una solidissima coscienza cristiana, la fin’amor configurava comunque un peccato. Su questo il fiorentino aveva sicuramente riflettuto tra la produzione della “Vita nova” e il progetto del poema sacro. La revisione allegorica della storia d’amore con Beatrice ebbe essenzialmente questo obiettivo. Ecco perché la aveva così descritta: cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare [“creatura venuta dal cielo sulla terra a mostrare miracoli”], cioè “angelo”. La fisionomia angelica della donna amata non è un’innovazione dantesca: basti come esempio il congedo di “Al cor gentil rempaira sempre amore” di Guinizelli. La novità sta nell’aver trasformato la donna nel tramite verso Dio: amarla significa amare il Creatore. Questa rivoluzione poetica avvenne con “Donne ch’avete intelletto d’amore”, la canzone programmatica sulla lode disinteressata, cioè senza fini di beneficio, contenuta proprio nella “Vita nova”. In sostanza, Beatrice allegoria della teologia pare già configurarsi nella prima opera dantesca.
Eppure, il dilemma sulla fin’amor non sembrava tuttavia essersi ancora risolto nel canto II dell’“Inferno”. Virgilio ha appena raccontato a Dante in un flashback che Beatrice, piangente perché mossa a compassione per lui, lo aveva inviato a salvarlo dalla selva oscura, e Dante stesso si è rimesso in forze spirituali proprio quando il latino gli ha nominato l’amata. Beatrice stessa aveva definito Dante l’amico mio (“Inferno”, II, 61), sintagma che, se andasse interpretato quale provenzalismo, equivarrebbe a “innamorato” (cfr. TLIO), accezione comunque presente nella “Comedìa” (cfr. “Purgatorio”, IX, 3). La donna appare molto umana e poco angelica in questo passo e Dante sentimentalmente legatole. Nulla a che vedere col rapporto che tra i due si sarebbe instaurato dalla fine del “Purgatorio” e lungo il “Paradiso”.
Dunque, come si comporta Dante nei confronti dei lussuriosi? La condanna è esplicitata dalle parole del Dante narratore (da non confondersi col Dante protagonista): i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento [“che sottomettono la ragione al desiderio”]. La condanna da parte del Dante protagonista (come detto, diverso dal Dante narratore) sembra invece non esserci. Difatti, lo svenimento finale non è determinato da fattori esterni, ma da un eccesso di pietade (v. 140): “compassione”, ovvero “sofferenza assieme a”. E questa commozione era già stata anticipata: quanti dolci pensieri, quanto disio menò costoro al doloroso passo! (vv. 113-114). A riprova, insomma, del fatto che il Dante protagonista, a questa altezza della “Comedìa”, non ha ancora pienamente accettato che la fin’amor sia un peccato!
C’è altro nel canto V che sostiene queste considerazioni? Ovviamente la coppia che parla con Dante, dato che incarna i princìpi dell’amor cortese: Francesca è sposata col signore di Paolo, suo fratello Gianciotto Malatesta, e Paolo la ama. Inizialmente l’amore è segreto (sanza alcun sospetto, v. 129), poi scoppia la passione (la bocca mi basciò tutto tremante, v. 136). La chiave di lettura dell’innamoramento è il v. 137: Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse. La doppia metafora si comprende solo alla luce della moda libraria medievale: Galeotto è il siniscalco che favorisce l’amore adultero tra Ginevra e Lancillotto, il libro in questione è sicuramente il “Cavaliere della carretta” e chi lo scrisse è di conseguenza l’autore Chrétien de Troyes. Tra le due storie praticamente parallele, quella di Ginevra e Lancillotto funse da exemplum per Francesca e Paolo. Quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante, ovvero già altre volte il sentimento li aveva avvinti (Francesca e Paolo scolorirono in viso: cfr. vv. 130-132), ma soltanto alla lettura della carnalità condivisa tra Ginevra e Lancillotto i due cedettero al peccato.
La condanna alla fin’amor da parte del Dante scrittore fu talmente convinta che sembra investire addirittura la letteratura in merito, persino Chrétien de Troyes! Il Dante critico letterario si era già espresso in sordina nella “Vita nova” e in maniera organica ma incompleta nel trattato universitario “De vulgari eloquentia”.
§ 2 Il verso diverso in questione Amor, ch’a nullo amato amar perdona segue in anafora l’altro celeberrimo Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, rivisitazione del guinizelliano Al cor gentil rempaira sempre amore. In tutta la produzione dantesca l’equiparazione amore – cuore nobile è una costante. A titolo di esempio basti il sonetto della “Vita nova” Amor e ’l cor gentil sono una cosa.
È interessante, tuttavia, sottolineare chi pronuncia quelle parole: Francesca. Non a caso entrambi i versi in anafora sono seguiti da una precisazione autobiografica. Nel primo caso, Francesca specifica che Paolo si innamorò della sua figura, che le fu strappata violentemente da Gianciotto (cfr vv. 101-102). Notiamo che l’accento della donna si concentra sul proprio aspetto esteriore, mentre la nobiltà d’animo è appena accennata. Nel secondo caso, Francesca conferma di essersi innamorata essenzialmente della bellezza fisica di Paolo, che ancora la lega a lui (cfr. vv. 104-105). L’intervento poi si chiude con l’anatema a Gianciotto, destinato al nono cerchio dell’inferno nella zona dei traditori dei parenti, la Caina (cfr. v. 105). Insomma, il richiamo alla fin’amor suona piuttosto come un’autogiustificazione al gesto peccaminoso compiuto.
La cornice è ormai delineata. Con tutte queste considerazioni pensare di ridurre il verso 103 al principio di reciprocità banalizza il turbamento che Dante dovette avvertire nello scrivere queste terzine, pronunciate sì da Francesca, ma almeno in parte da lui condivise.
Dunque come si potrebbe spiegare questo celeberrimo verso? Quel che segue deve tutto all’intuizione del prof. Bernabei.
Ecco la lettura con la corretta pausa metrica e sintattica: Amor, ch’a nullo | amato amar perdona. L’endecasillabo è a minore (ovvero con accento ritmico sulla quarta sillaba) e nullo e amato appartengono a sintagmi diversi. Ne consegue questa lettura senza inversioni retoriche: Amor, ch[e] perdona a nullo amar amato. Da parafrasare: “Amore non risparmia a nessuno di amare l’amato”.
Il verso acquista così una semantica totalmente diversa: si tratta del principio di non contraddizione, forse banale concettualmente, ma del tutto coerente con il contesto. In altre parole: “Amore non permette a nessuno di non amare il proprio amato”. Questa frase certifica l’indissolubilità del legame amoroso tra amanti che si corrispondono e allo stesso tempo rinforza la condanna del Dante narratore di qualche verso prima: se una persona non può resistere al richiamo d’amore quando peccaminoso, significa che ha sottomesso la propria ragione al piacere sessuale. Francesca si sta autocondannando inconsapevolmente, il Dante protagonista partecipa turbato a questa autocondanna, il Dante narratore (consapevole di ciò solo perché ha già completato il suo viaggio di redenzione) non si fa coinvolgere emotivamente. E il Dante autore/uomo? Dobbiamo ritenerlo la guida morale che ha visto Dio o affiancarlo al Dante protagonista? Sarebbe interessantissimo indagarlo.
Per sostenere questa nuova interpretazione, il prof. Bernabei cita addirittura il manuale della fin’amor, il trattato “De amore” di A. Cappellano. Il testo è tardo rispetto alla tradizione trobadorica, ma precedente quella italica, quindi Dante sicuramente lo lesse. Non dimentichiamo che il terzo libro dell’opera condanna integralmente la teoria amorosa esposta nei primi due, proprio per le considerazioni riportate sopra. Ebbene, il chierico afferma: Amor nil posset amore denegari “Amore non può negare nulla all’amore” (II, 8, 48). È, nella forma teorica astratta tipica di un trattato, lo stesso principio di non contraddizione contenuto nel verso in bocca a Francesca nella “Comedìa”, tra l’altro con lo stesso esito finale: la condanna cristiana dell’amore adultero.
Professore, sostengo la sua interpretazione!
Francesco Pozzato
______________________________
Riflessione
Il buon insegnante si sforza di portare i discepoli al suo livello, non di scendere al livello dei discepoli.
L’Alighieri non ha scritto in volgare per essere letto dal popolo, ma per conferire al volgare una dignità lette-raria.
Rendere popolare Dante è un falso problema e un’ingannevole promessa.
La Divina Commedia non è un canovaccio per gli show, ma un testo per lo studio, la riflessione, il godimento estetico. Non basta commuovere con espedienti analo-gici (gesti e uso della voce) per trasferire la sublime letteratura dantesca (pensiero, lingua e poesia)! Per comprendere un linguaggio è necessario apprenderlo.
Il Dante di Benigni è un inganno ed è la docenza nelle mani dell’incompetenza.
O Dante o Benigni!


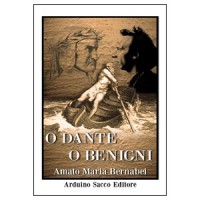
Egregio Dott. Bernabei,
Ho letto con interesse la sua esegesi e devo dire che mi convince.
Tuttavia vorrei sottoporle brevemente la mia interpretazione che, tengo a sottolinearlo, è quella d’un inesperto, d’un semplice lettore; anzi, con molta probabilità, le sarà già nota.
Ecco il mio commento:
Dante, nel famoso verso, vuole descrivere un amore connotato da egoismo; si tratta di quel sentimento amoroso che, una volta impossessatosi dell’uomo, non tollera (nullo… perdona) che il suo oggetto (la persona amata) non lo contraccambi.
Dunque accade che ciò che si ama non è, in definitiva, la persona amata, ma se stessi: “Io t’amo, quindi voglio, pretendo, che tu contraccambi!” Questo mi sembra di sentire quando leggo il verso. Inoltre, riflettendoci bene, il sentimento così descritto può manifestarsi tanto nel caso di amore corrisposto, quanto nel caso di un amore respinto.
In conclusione, mi sembra che questo sentimento egoista si ponga in contrasto frontale con l’amore di Dio verso l’uomo, il quale è connotato da assoluta gratuità. Qui mi fermo, perché ho già sconfinato in campi che conosco poco.
La ringrazio per l’attenzione
Distinti saluti,
Alessandro
Gentilissimo Alessandro, mi è difficile immaginare come motivato da altruismo un amore punito da Dio. Credo quindi che l’egoismo di cui lei parla sia senz’altro caratteristico del peccato di lussuria tormentato per l’eternità nel secondo cerchio dell’Inferno dantesco.
Sono meno convinto che il verso di cui ci occupiamo voglia alludere alla pretesa del contraccambio. Nella comunicazione non si può prescindere dal codice usato ed è quindi necessario tener conto delle leggi che lo regolano. La mia interpretazione non perviene infatti alla formulazione di un significato possibile in maniera indipendente dal sistema linguistico: i nessi della grammatica sono fondamentali, e gli elementi presenti nel verso acquistano semantica in forza dei collegamenti logici e sintattici; e questi sembrano portare all’esclusione dell’intolleranza, da parte del soggetto che ama, per il rifiuto che l’oggetto amato opporrebbe, e andare piuttosto nella direzione di un principio che generalizza l’impossibilità per chiunque di sottrarsi a un sentimento corrisposto. Naturalmente io posso anche ingannarmi, ma le mie argomentazioni vogliono dimostrare soprattutto questo.
Sarei perplesso, poi, anche sulla qualità “gratuita” dell’amore divino, dal momento che esso “pretende” il rispetto dei comandamenti, mancando il quale l’oggetto d’amore, l’uomo, irrimediabilmente è condannato alla pena eterna. Questo è però un discorso per teologi, più che per letterati, e lo lasciamo quindi a chi ne sa più di noi.
Cordialmente
Professore Buongiorno.
Vorrei commentare questi celebri versi. Sinceramente ricordavo diversamente, ma sicuramente ricordo male anche perche sono passati 30 anni dal mio 3° Liceo. Dunque il verso in questione dice:
Amor ch’a nullo amato amar perdona
Facciamo l’analisi logica.
Amor : Soggetto = “Amore” inteso come il dio Amore.
ch’: congiunzione logica
a nullo amato: complemento di termine e credo si possa rendere come “alla persona non amata”
Amar: complemento oggetto e lo rendo come “il fatto di amare”
Perdona: predicato verbale “consente” oppure “lascia che sia”
Nel verbo non compare in alcun modo la negazione.
Io lo rendo così:
Amore consente (lascia che accada che) alla persona non amata di amare. Cioè permette un amore non corrisposto. Ora ho capito perfettamente che in quel periodo l’amore era legato alla bellezza, alla gentilezza al valore per cui un uomo bello, nobile o valoroso che amasse una donna bella, colta e gentile non poteva che essere riamato. E’ perfettamente in linea con il dolce stilnovo e l’amor cortese.
Nell’analisi che faccio io si vede Amore consente che esista questo sentimento amoroso non corrisposto solo per un lasso di tempo iniziale e solo poi “mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona”. Ovvero nel momento che l’amore non è più segreto perchè si rivela, allora e solo allora, viene corrisposto, ma fino ad allora Amore aveva consentito alla persona non amata di amare. Ripeto ho grossa difficoltà a pensare alla presenza di una negazione sottintesa nel verbo perdona o ad intendere “perdona” come “non permette” . In questo modo la corrente letteraria dell’epoca che vuole un amore puro, gentile, bello e colto rimane salvo perché comunque si realizza. In un certo senso giustifica anche l’amore che Dante provava per l’eterea Beatrice e che di fatto era non corrisposto. Cosa ne pensa?
Saluti e complimenti perle sue analisi.
Fabrizio