* * *
IL VETRO DI NARCISO
1° Premio per la sezione Prefazione
XVIII Premio Nazionale Città di Forlì 2021
Premio per la sezione Poesia Edita
Premio Nazionale “I Murazzi” 2022 Torino
2° Premio per la sezione Silloge edita
del Premio Letterario Internazionale di Penne 2022
Nella cinquina dei finalisti
Premio Letterario Internazionale Arce 2022
* * * * * * *
Così, come Narciso che si guarda,
immobile e sospeso, e nel riflesso
coglie se stesso e il mondo dentro un vetro…
><<>><
Nota dell’autore
Umberto Galimberti riferisce [1] che nel 1898 Havelock Ellis e Paul Näcke introdussero il termine narcisismo per indicare quella “perversione sessuale in cui l’oggetto preferito dal soggetto è il proprio corpo” (Näcke utilizzò la parola narcisismo in riferimento a uno studio di Ellis sulle perversioni sessuali [2], in cui questi, trattando il fenomeno dell’autoerotismo, aveva coniato la locuzione “narcissus-like” per denotarne l’eccesso). Nel 1936 “Jacques Lacan introduce nella psicoanalisi freudiana la locuzione di fase dello specchio, intesa come momento in cui nella mente infantile si comincia a costituire il nucleo dell’Io”. Il bambino si riconosce allo specchio e gode, divertito, della sua immagine.
Oggi si dice narcisista, per estensione, chiunque evidenzi un culto esagerato di se stesso; tuttavia il termine narcisismo definisce anche “un assetto generale dell’individualità di ciascuno, elemento che consente uno stato di autoconservazione, di adeguata valutazione e stima di sé” (Pierluigi Moressa).
Caravaggio, dipinto del 1599, Galleria Nazionale d’Arte Antica – Roma
La premessa vuole avvertire che io credo che l’artista “si guardi” in modo narcisistico, secondo l’impossibile specularità del Narciso caravaggesco, che non inverte il riflesso… “Provate a capovolgere un oggetto: ciò che in alto era a sinistra in basso è a destra. Non così appaiono i due volti di Narciso: in alto o in basso sono sempre la parte ‘sinistra’ e la parte ‘destra’ del volto. Anche rovesciati sono sempre nella stessa posizione” [3]. Manifestazione all’altro attraverso un’ottica illusione che mira a preservare, a difendere l’io più segreto, a conservare la propria intimità; consegna di sé come abbaglio, che tende ad eludere una possibile intrusione. Contemporaneamente l’artista s’indaga secondo l’immortale sentenza iscritta nel tempio di Delfi: ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ, Nosce te ipsum, conosci te stesso! Egli è dunque perennemente proteso a un ripiegamento, sia in una soddisfacente autocontemplazione estetica, che nel compiaciuto percorrere i sentieri del proprio essere, verso l’acquisizione del macrocosmo tramite la conquista del microcosmico sé.
Il vetro di Narciso è appunto lo spazio dell’io che si ammira e si cerca, decidendo di far partecipi gli altri di tale atteggiamento e di siffatto processo, non al punto da consegnarsi integralmente, ma trattenendo gelosamente il Νάρκισσος, la parte di sé più recondita e compiaciuta, e giammai condivisibile. Né va trascurato il senso che più si stringe all’etimologia (νάρκωσις «torpore»), per cui l’artista vive nel piacevole intorpidimento dell’estasi che la sua arte gli produce, come per incantesimo, e insieme, per quella componente del termine che richiama il mondo dei morti, come anima privilegiata si spegne al mondo, che non lo comprende e lo respinge, isolandolo nella sua feconda, e per troppi inaccessibile, creatività [4].
Non mi pare convincente, invece, l’interpretazione per cui “Narciso scambiò la propria immagine riflessa nell’acqua per un’altra persona e quest’estensione speculare di se stesso attutì le sue percezioni fino a fare di lui il servomeccanismo della propria immagine estesa. Narciso era intorpidito. Si era conformato all’estensione di se stesso divenendo così un circuito chiuso. […] Il senso di questo mito è che gli esseri umani sono soggetti all’immediato fascino di ogni estensione di sé, riprodotta in un materiale diverso da quello stesso di cui sono fatti” [5]. Perché innanzi tutto il giovinetto era impermeabile agli altri e predisposto a reclinarsi su se stesso prima ancora di specchiarsi nella sorgente dove si sarebbe appreso e condannato. La profezia di Tiresia aveva annunciato alla Ninfa Liriope, madre di Narciso, che suo figlio sarebbe vissuto a lungo, a patto di non pervenire alla conoscenza di sé. È il “conoscersi”, con l’immediato acquisire l’altro da sé, che perde il giovinetto, il recepire consapevolezza di non potersi rapportare con il mondo esterno, di non essere capace di amare, se è vero che il solo “amore” di sé tradisce l’essenza stessa del sentimento amoroso, orientato per costituzione ad un oggetto altro. La morte di Narciso è la metafora dell’amore già morto nell’attenzione che il giovinetto riserva solo a se stesso, è l’avverarsi di un destino di morte da una natura di morte. L’amore “che vive” ama fuori da sé. D’altra parte ritengo sostanzialmente diverso il ripiegamento su di sé, con la conseguente esclusione del mondo circostante, che a mio avviso è la chiave di lettura del mito di Narciso, dall’estensione in altro da sé (“l’altra persona” di cui parla McLuhan), che è forse più applicabile al mito di Pigmalione, lo scultore che si proietta, “amandosi”, nella statua di Galatea, incarnazione del suo ideale di donna.
Comunque la poesia dell’ “artista Narciso” demiurgicamente “fa essere il mondo, lascia essere l’essere. Lo lascia fiorire” [6], sboccia e resta, sulla sponda della tragica fonte, profumo che si spande e perennemente si rinnova da un fiore odorosissimo.
[2] Havelock Ellis, Studies in the Psychology of sex, vol. II (Sexual inversion, scritto con J. A. Symonds nel 1897).
[3] Vincenzo Cocozza, Il cantafavole concettuale, Allinea, 2004, p. 70.
[4] Cfr. l’Inno omerico a Demetra, vv. 8 ss., dove si narra di un favoloso narciso che affascina irresistibilmente Persefone, che al momento di coglierlo, sprofonda nella “terra dalle agevoli strade”, che si spalanca, fra le braccia del Dio “che molti accoglie”. Il fiore, collegato alle figure di Demetra e di Persefone, ha nel mito anche l’implicazione simbolica della fertilità e delle messi (Anna Ferrari, Dizionario di mitologia greca e latina, UTET, 2006, p. 485 alla voce “Narciso”).
[5] Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, 2008. [6] Daniele Capuano, Riflessioni su Narciso,
QUARTA DI COPERTINA
Il vetro di Narciso è l’altra faccia della vertiginosa avventura espressa nel poema Mythos, pubblicato nel 2006 e consistente d’oltre diecimila versi in terzine dantesche, sostituendosi qui alla maestà delle figure del mito l’esperienza del singolo uomo nel confronto quotidiano con giorni, stagioni, epoche della vita. A suggello della raccolta è posto un personaggio che raffigura il dilemma tra l’incantamento procurato dall’ammirazione della bellezza e la sua contemplazione autoriferita in uno sguardo solitario e sterile. Ma l’autore, in realtà, dà corpo ad un Narciso ben differente rispetto alla tradizione: il richiamo, infatti, non è tanto al giovane innamorato esclusivamente di sé e di nessun altro, quanto al vetro-specchio con la sua capacità di riflettere, rimandare e replicare, senza tuttavia poter davvero fissare alcunché. L’immagine che in esso si staglia è effimera, destinata a modificarsi e svanire al minimo e naturale movimento di chi, appunto, vi si sta specchiando. In questo senso, il vetro di Narciso è la poesia stessa: la meditazione dell’autore si colloca in questo interstizio tra l’aspirazione a disvelare e cristallizzare l’eternità presente negli avvenimenti, la quale è bellezza di per sé, e l’inevitabile sottomissione al tempo che incessantemente trascorre. Lo sguardo di Bernabei ci offre così un altro Narciso, quello che sa resistere all’illusione e alla fascina-zione dell’immagine superficiale per immergersi in una esplorazione di quanto sta dietro lo specchio. L’intento è già nei versi in esergo: “Così, come Narciso che si guarda, / immobile e sospeso, e nel riflesso / coglie se stesso e il mondo dentro un vetro”. Coglie se stesso, perché è impossibile fronteggiare uno specchio senza vedere anche la propria immagine, ma non al punto d’essere distolto dal cogliere anche il mondo, secondo una reciprocità che pervade l’intero libro e che trova compendio in un verso dedicato alla donna amata: “l’universo / guardato nel tuo sguardo”.
Proprio l’amore costituisce il cardine e l’argomento principe dell’intera raccolta, non come concetto astratto o idealizzato bensì concretamente proteso alla figura amata, facendo tesoro di una lunga tradizione lirica (da Saffo a Catullo, da Petrarca a Shakespeare fino alla lirica spagnola) le cui tracce stabiliscono una connessione, logica e psicologica, che conferma la sostanziale impossibilità di vivere – e scrivere – un autentico sentimento d’amore essendo, contemporaneamente, dei “narcisi”. Amare è la capacità di uscire da se stessi nella piena comprensione, nell’apprezzamento sincero, nel rispetto dell’alterità, qualità tutt’altro che narcisistiche: quello di Amato Maria Bernabei si rivela essere, così, una sorta di “Narciso estetico” capace di valorizzare in toto, assai prima di sé, il mondo che lo circonda.
Stefano Valentini
* * * * * * * *
PREFAZIONE
Chiunque abbia avuto cognizione diretta o indiretta di Mythos, poema d’oltre diecimila versi in terzine dantesche pubblicato da Amato Maria Bernabei nel 2006 e opera senza eguali nel panorama della nostra letteratura moderna e contemporanea (si leggano, per farsi un’idea, gli autorevoli giudizi riportati ad apertura del volume), sarà forse sorpreso da questa raccolta. Se lì entrava in gioco una vastissima erudizione, variamente articolata e compendiata, qui a prevalere sono la delicatezza, la piana colloquialità (formale e sostanziale), il desiderio di cogliere l’istante minuto – sia pur intriso di potenziale eternità – piuttosto, come in quel libro, del generarsi della Storia attraverso le sue immortali leggende. Non si tratta, comunque,di un’attitudine inedita avendo l’autore già pubblicato, una trentina d’anni fa, un paio di raccolte costruite attorno ad un’ispirazione, per così dire, intima e personale. Va peraltro subito detto che non sussiste alcun conflitto, né ancor meno contrapposizione, tra le due modalità: Il vetro di Narciso non contraddice Mythos né la grandezza di Mythos sminuisce la presente raccolta. Si tratta, semplicemente, di una diversa articolazione della medesima personalità poetica, differentemente vissuta e filtrata. Né vengono certo meno l’eleganza e la maestria formale, che risultano anzi magnificate nella parola, libera da ogni schema ma ugualmente esatta, calibrata, plasmata e avvolgente: il valore del verso, come entità autonoma, rimane un elemento fondamentale, anche quando franto in virtù di marcati enjambements, così come avviene nei versi più brevi e sincopati che rimandano anch’essi, sempre, ad un’idea-partitura musicale. È del resto evidente, anche in un’opera come questa, l’intenzione idealmente poematica, l’aspirazione a qualcosa che non sia puro assemblaggio di testi sparsi o d’occasione: paradossalmente, questo si compie grazie ad una scansione rigidamente temporale, con date riportate fedelmente (nell’originale addirittura con l’orario di stesura, in fase di stampa eliminato perché poco interessante per il lettore). L’autore affida al calendario la successione delle poesie, senza alcun agglutinamento o riordino tematico: le poesie sono incasellate come attimi sottesi al fluire dei giorni non per evidenziarne l’occasionalità, ma al contrario proprio per marcarne l’universalità e l’indipendenza rispetto a qualsiasi successiva ricognizione o riordino “a freddo”. La direzione dei giorni è una, fatte salve le prerogative della memoria, e a questo dominio l’autore non desidera sottrarsi: seguendo il flusso del tempo e delle circostanze, sottomette l’intelletto (e l’intenzionalità) alla realtà delle cose e alla verità dell’istante, affinché ogni istante possa mostrarsi assoluto proprio conservando la sua posizione, anziché astraendosene. Sono tante piccole singolarità, come direbbe la moderna fisica, tante manifestazioni di quella realtà che si proietta oltre “l’orizzonte degli eventi”. Sicché anche le insistenze, i rimandi, le iterazioni fanno parte di quel tessuto-trina che nell’apparente levità, nell’apparente fragilità dell’attimo che si manifesta e svapora, recupera invece la sua forza tenace: è proprio nel suo rarefarsi che, per ulteriore paradosso, la trama del tempo si compatta.
Per tutte queste ragioni, Il vetro di Narciso è l’altra faccia della vertiginosa avventura espressa nel precedente poema, sostituendo qui alla maestà delle figure del mito l’esperienza del singolo uomo nel suo confronto quotidiano con giorni, stagioni, epoche della vita. Né dal mito comunque si prescinde, se una delle sue incarnazioni più celebri viene posta a suggello dell’intera raccolta, quel Narciso da sempre assunto a raffigurazione di un dilemma irrisolto: quello generato nel contrasto tra l’incantamento procurato dall’ammirazione della bellezza e la sua contemplazione autoriferita in uno sguardo solitario e, in quanto tale, sterile. Bastano tuttavia le prime pagine del libro per comprendere come il riferimento a Narciso risulti ambiguo o, per meglio dire, variamente sfumato e sfaccettato. Potrebbe semplicemente essere un “mettere le mani avanti”, quasi una excusatio dell’autore se, dopo il grande poema (e il successivo dramma Passio, anch’esso in terzine dantesche, di dimensioni assai più contenute ma di vasta portata immaginifica e speculativa), propone oggi al lettore “soltanto” una raccolta di singole poesie, quasi fosse (e non è) manifestazione di personale vanità. A nostro parere, invece, l’idea di fondo è molto più sottile: dare corpo ad un differente Narciso rispetto a quello della tradizione. Il richiamo, infatti, non è tanto al bellissimo giovane innamorato esclusivamente di se stesso e di nessun altro, quanto al suo vetro-specchio: non la persona di Narciso, quindi, con i suoi discutibili limiti, ma l’oggetto nel quale si riflette e che gli procurerà il suo tragico destino. Non l’animo di Narciso, quindi, viene qui indagato (né per magnificarlo né per biasimarlo), bensì lo specchio con la sua capacità di riflettere, rimandare e replicare, ma non di fissare alcunché. L’immagine che in esso si staglia è effimera, destinata a modificarsi e a svanire al minimo movimento di chi, appunto, vi si sta specchiando: è un dipinto-ritratto istantaneo, per sua natura privo di qualsiasi durevolezza. In questo senso, il vetro di Narciso è la poesia stessa: la meditazione dell’autore si colloca proprio in questo interstizio tra l’aspirazione a cogliere e cristallizzare l’eternità presente negli avvenimenti, che è bellezza di per sé, e l’inevitabile sottomissione all’istante che incessantemente trascorre. Non è affatto detto, pertanto, che in questo specchio si debba per forza perdersi, come lo sfortunato Narciso. e se poi, come nella leggenda, è appunto uno specchio d’acqua, quanta vita allora si nasconde e agita sotto la sua superficie in apparenza immota, quanti dettagli! Impossibile non subire la suggestione letteraria resa immortale dal francese Vercors con il suo romanzo Il silenzio del mare. Ecco, lo sguardo di Bernabei ci offre così un altro Narciso, quello che sa resistere all’illusione e alla fascinazione dell’immagine superficiale – pur inseguendone, grazie al proprio talento, la bellezza – per immergersi in una esplorazione di quello che sta al di sotto, dietro lo specchio (o attraverso, verrebbe da dire con Lewis Carroll). Il “programma”, chiamiamolo così, è già nei versi in esergo: “Così, come Narciso che si guarda, / immobile e sospeso, e nel riflesso / coglie se stesso e il mondo dentro un vetro”. Coglie se stesso inevitabilmente, perché è impossibile fronteggiare uno specchio senza vedere anche la propria immagine, ma non al punto d’essere distolto dal cogliere anche il mondo attorno, sopra, alle proprie spalle e nel vetro stesso. È insomma, come Bernabei dirà in un verso dedicato alla donna amata, “l’universo / guardato nel tuo sguardo”.
Indicativa, comunque, è anche la concisa ma dotta nota introduttiva: «Il vetro di Narciso è appunto lo spazio dell’io che si ammira e si cerca, decidendo di far partecipi gli altri di tale atteggiamento e di siffatto processo, non al punto da consegnarsi integralmente, ma trattenendo gelosamente il Νάρκισσος, la parte di sé più recondita e compiaciuta, e giammai condivisibile», con molto altro che segue. Del resto, se il cosiddetto “narcisismo” ha assunto nel corso del tempo (e in ambito psico-comportamentale) una connotazione prevalentemente negativa, è soprattutto per le sue manifestazioni estreme e deteriori, non di rado legate alle cronache: laddove ne va invece considerata la dimensione per così dire naturale e positiva, quella della conoscenza e scoperta di sé che è precondizione necessaria alla conoscenza e comprensione dell’altro da sé. Non vi è infatti alcun dubbio che Bernabei attribuisca alla poesia, anche la più apparentemente privata e personale, una funzione conoscitiva di respiro universale. Non potrebbe essere che così: quanto poco narcisismo, inteso come sentimento controverso o limitante, emerge in questo libro! Nessuna autoreferenzialità, semmai proprio il contrario, come vedremo parlando dell’amore che è il principale motore della raccolta e dell’atteggiamento-attitudine esistenziale che ne sta alla base. Dice comunque più avanti, nell’unica lirica in cui Narciso appaia direttamente: “Chi specchia, o quale azzurro lo contiene? / È impropria la bellezza o gli appartiene? / … / ride di giovinezza e piange al riso / lo sguardo che si guarda ed è diviso. // Narciso è come l’acqua e sa che il vento / lo spegne e lo ridesta in un momento. // Narciso è l’acqua che nell’acqua annega / di trasparenza che si svela e nega, // muore di sé, del suo pensiero intento, / nell’acqua che si ferma dentro il vento”. Peraltro, altrove leggiamo ancora: “E resta sempre come in un diviso / spazio, cristallo in parte in parte specchio, / quello che vedi e pensi e senti vano”. La vera tragedia è quella della duplicità che non trova compendio e armonia, quel compendio e armonia che la poesia insegue e realizza: Narciso affoga proprio perché non ha saputo essere poeta.
Non si tratta quindi di non voler dire tutto per avarizia o pudore, ma piuttosto di non poterlo fare, a causa della parte indicibile e inesprimibile che abita in ciascuno di noi e nella realtà medesima: ancor più, si tratta di accettare (da parte di chi ascolta e da parte di chi scrive) questa irraggiungibile completezza. Nella raccolta si realizza un continuo rincorrersi tra ombra e luce, un fondo crepuscolare che non è affatto quello dell’omonima corrente novecentesca, poiché immerso qui in una dimensione di eterno e di assoluto. Un gioco di penombre dove raramente si realizza lo sfolgorio della luce piena ma dove mai, mai, c’è veramente buio. Consideriamo il primo testo: “Non riconosco i calici che aprivi, / appena, come un fiore capovolto, / l’ombra si ritraeva. / Eppure l’alba sembra ancora fresca / e qualche foglia brilla ancora gocce / della notte perduta”. Una ouverture di bellezza quasi ipnotica, una definizione di coordinate dalla quale si ricavano indizi importanti: la presenza di una negazione (che non contraddice davvero ma, semmai, allarga la prospettiva) seguita da un “eppure” che rimette in gioco ogni certezza. Ancora: “Ridammi i giorni degli occhi smarriti / come distratti nell’atrio di un sogno”: lo sguardo alla vita fuggita, la presenza dello smagamento onirico (illusorio?), la deprecazione del tempo che “gode il furto / inconfessato delle cose belle”. Fino alla conclusione: “Voglio quegli occhi puri come / pioggia / che nacque, come il primo vento / che si svegliò da un sonno mai dormito, / il primo raggio dopo un sole spento”. Classicità assoluta nella musica dell’endecasillabo ed eleganza, altrettanto assoluta, nella melodia dei concetti, con il richiamo ad un desiderio di purezza in un contesto che ha le sfumature di una primordialità innocente e mitica. Tutto il libro è così, una finissima tessitura di emozioni e concetti, d’intelligenza (nel senso più puro) e amore, tanto nelle liriche più articolate che nelle molte poesie brevi o brevissime, addirittura concluse in quartine o distici o persino singoli versi, secondo la lezione di Giuseppe Ungaretti (non tanto dal primo, così universalmente noto e frainteso, quanto dal maggiore, quello della riscoperta della forma). Sono insomma testi da assaporare tanto nella lettera quanto nelle sfumature, non semplicemente ascoltando ma ponendosi per così dire “in soggettiva” dalla parte dell’autore, immedesimandosi in lui e nelle sue esperienze anche sensoriali: c’è infatti un’insistita evocazione dello sguardo, degli occhi, dei colori e delle stagioni, una disponibilità allo stupore contemplativo che indugia tra meraviglia e sgomento, un dialogo tra assenza e presenza, tra memoria e desiderio, assecondando una dialettica degli opposti che produce sempre, come per tensione naturale, un fondersi il più possibile armonioso.
C’è, soprattutto, un tu quasi sempre femminile, non idealizzato ma reale, cui il poeta si rivolge con parole d’amore che si coagulano in liriche abbaglianti, compostamente classiche e appassionate al tempo stesso. “E ti ringrazio quando / mi accorgo che sei giorno e che sei vita, / mentre ogni cosa si abbandona e muore. / Io ti ringrazio quando scende l’ombra / e sei la prima, e un’altra e un’altra luce / dell’aria che si stella / e la speranza / che l’orizzonte porti ancora un fiore”. L’amore, incarnato nella donna prima ancora che ideale, è il “segno più profondo / della vita”, secondo un’idea di profondissima comunione in grado di vincere ogni differenza: “E devo pensare che tu / sai tremare come questo / senso di vivere / che porto dentro / … / devo pensare che sai guardare / come guardo / il mattino quando nasce / e i fiori al labbro / degli steli e l’irrequieta anima / dei voli sospesi, ma già tesi / ad altri voli / … // Devo pensare che tu senti / quello che sento e sai capire / le parole, / che le parole sono il vento / del cuore acceso. // Che sai leggere i versi che ti scrivo / come li scrivo, / che più dei segni tu raccolga il mare / che non ha spiagge / e una lampara per il tuo vascello / dentro le notti”. Un’idea salvifica non tanto dell’amore in sé, come detto, ma della presenza concreta di lei, apparsa come la rivelazione di qualcosa (“eri un profilo della mente, vano, / composto sul silenzio di un cuscino”) in precedenza indistinto e inconsapevole: “tu che ritrami il tempo e la mia vita / e intessi scene che non ho vissute”, “tu che muovi / il fermento e il sipario delle scene”, con “le labbra al cerchio strano che si avvia / da un respiro e in respiro si confonde, / anima tua… o forse anima mia, / o solo questo amore che ci fonde”. Cita un salmo biblico per dirle “racconterò tutte le tue meraviglie” e la circonfonde di un “incanto puro che sorprende / del suo stupore l’anima e la tende / all’infinito che si apre”. Ne sono coinvolti i sensi (“all’orlo della bocca che si schiude / in vergine sapore e sa di fiamma / che si riaccende mentre il mondo muore”) non meno dell’intelletto, danzando tra la dolcezza dell’ingenuità innamorata (“per certi lampi dei tuoi occhi / vendo il cielo. / E se qualcuno obietta / che rinuncio a galassie per due stelle, / gli dirò che ti guardi”) e l’iperbole enfatizzata (“l’amore scritto già nelle spirali / che svolgevano il mondo”, “non credo alla morte / e so che potrai baciarmi / fra mille anni”, “saremo vasti / di spazi siderali, eterni al tempo / e padroni dell’ombra e della vita”). È un amore che irrompe, che scuote, che rigenera: “Gemma ancora di gemma, eppure frutto, / tempo disperso ed il presente eterno… / tu, non ancora bacio e già violento / abbraccio, e già passione, e già tormento, / donna che non sapevo di aspettare, / venuta quella sera, come un vento”, a suscitare “il fresco gemito / dell’anima colpita” e la cui presenza attiva diviene parametro assoluto, sia per quanto concerne la vita del poeta (“il vuoto è la tua bocca che finisce, / il tuo sguardo / che non mi contiene”) sia per quanto attiene alla stessa realtà (“qualunque notte scura, / soltanto se ricorda / come la guardi, / splende”). Soprattutto, è un amore ormai imprescindibile: “Sentirti è l’acqua fresca alle caviglie, / il brivido nel corpo, / il sole che si specchia e ripettina / il fuoco, l’onda che trema” e dunque, invoca il poeta, “dammi torrenti nuovi anche domani / e di torrenti bagna le mie rocce”. Qui, se c’è un vetro nel quale specchiarsi, il vetro è (o riflette) l’amata, non certo l’io del poeta.
Un amore, dunque, “sconfinato e stretto / nel cerchio di un abbraccio, come il sangue / totale e circoscritto come il senso / di una parola”, mentre “il tempo / scorre su tutto e lascia un’emozione”. Ma appunto, assieme all’amore, l’altro protagonista del libro è lo scorrere del tempo, secondo una duplice prospettiva: quella di chi ambirebbe a sottrarlo alla precarietà, tramite il potere della parola che cristallizza l’istante, e in esatta contrapposizione quella di chi ne avverte la sgomenta, inarrestabile fuga. L’uomo, e con lui l’uomo-Bernabei, è costretto a dirimere questa dimensione duplice tra un possibile eterno e il timore che esso, pur esistendo come idea e aspirazione, non sia attingibile. Eterno, qui, equivale a mistero, quel mistero la cui labilità è difficilissima da afferrare (“la sorpresa di specchiarsi, come / in una lenta acqua che si rompe / se batte il vento”) e si nasconde dietro le minime cose, nell’enigma delle circostanze inappariscenti: “Come trapassa – e non ritorna indietro -, / quello che solca e sembra non incida, / lasciando incanti a un vetro di sipario / sull’orizzonte”. Vi sono, nel libro, rimandi continui a questa realtà velata, nascosta: “Io ti ringrazio per il grande sguardo / come uno spazio che si scopre cielo / dentro infiniti vuoti neri, e quello / strappo di luce che non sa se voglia / o se lo schiuda uno smarrito senso, / un desiderio senza bordi, un sogno”. Ed è precisamente la dimensione del sogno che spesso offre la necessaria “luce che dilata la pupilla”, provando a fermare l’attimo che sfuma (“l’attesa guarda il fiume che rallenta”). lo sguardo che si protende al mistero non è mai solipsistico, anche quando sembra centrato sul sé si fa invece carico della condizione umana, quasi un invito a spingersi oltre (“dilato il varco che disserri il volo, / perché tu senta il cielo e il vento inciso”) e a rinnovarsi, cogliendo “le infinite / tinte delle sorgenti nuove”. Appaiono puntini sospensivi, a suggerire l’indicibile e l’insufficienza delle parole che “nemmeno sono segni sulla riva, // grappolo che si coglie e che profuma, sapore al labbro, gusto che già sfuma”. Non è sfiducia nella poesia, del cui importantissimo ruolo già abbiamo detto, ma la consapevolezza di come eterno e mistero possano nascondersi anche nelle pieghe dei significati, in un canto “senza sintassi e senza intendimento” o dietro “l’anonimo fonema dentro il senso”. Non tutto si può esprimere, come ben ammise Dante al termine del suo viaggio: “A l’alta fantasia qui mancò possa”. La ricerca di Bernabei non ha, come traguardo, necessariamente il divino, se non nelle forme che si manifestano nel creato e nel cosmo: una semplice creatura alata è “pura come la vita che conosco, / immune ancora e fervida di gemma”, innocenza primigenia da cui tutto può ancora originarsi e rigenerarsi. È l’intercapedine tra il “tempo cieco” delle primavere e il “tempo d’occhi vivi senza tempo”, è “questo improvviso tempo di fontane, / acqua che non versava e che dilaga, / che all’anima ridà questo improvviso / tempo di eternità”. Per altro verso il tempo, questo grande divoratore, di per sé sembra addirittura non esistere, se sottratto all’umana percezione: “Ho dato una cadenza al tempo / che non sa scandire / e come cera ha solo / le infinite forme che la mano / crea”. Ecco qui un’altra possibile declinazione del vetro di Narciso: il riflesso può distogliere, può essere ammaliante e pernicioso, ma senza quel riflesso istantaneo non può esservi neppure “un labile presagio di profumo / eterno”, poiché “di attimi / vive l’eternità”. L’incertezza del domani non è ragione sufficiente per ritrarsi dalla vita, tutt’altro: “Dammi, vento, il tuo vino e dammi il succo / di ogni vite spremuta, dammi il senso / nebbioso del giudizio che discorda, / il senso in altalena fra la mente / che conosce il segreto ed il coppiere / che lo svuota… se come l’usignolo / non so se canterò / e se domani ci sarà la rosa. // Il passato che si riaccende, / che sembra vivo / nello stesso fiore?”. Sembra lo stesso fiore, ma non è.
Tempo, ovviamente, significa finitezza: il fiore autunnale che pare “pregare nel profumo / di una festa che finisce”, “l’istante che passa nell’anima / che prima non c’era, / che adesso è finito”, mentre “il giorno che abbaglia si lista / già d’ombra”. La finitezza è condizione collettiva, ma l’amarezza e lo spaesamento spettano ad ogni singolo individuo: “Che ne sarà di quello che ho sentito / e nessun altro / potrà?”. Siamo “assortite dissolvenze”, “parvenze che si aggirano / nei gesti uguali, / e che già sono / le ombre che saranno, in altre forme, / anche se in questo / eterno genere che pensa / e cade”. Come ha detto Pascal: siamo fragili canne, ma canne che pensano. Caducità e desiderio di permanenza (di noi, di qualcosa) in lotta tra loro, nel corso di un’esistenza che trascorre “come un giorno di farfalla”. La mente oscilla tra razionalità e possibilità, si appella ora ad altri orizzonti filosofici (“Ma forse una lanterna / già si aggira / dentro il fiume del tempo / che non scorre, / una scintilla che ritorna / al fuoco / in cui la fiamma / è / SEMPRE”, “Il mare dell’oriente ha già pensato / quest’ora, / e tu ritorni al luogo ininterrotto / che si ripete, / e muta in apparenza dove guarda / sempre infinitamente / il suo finito”) ora al raziocinio dell’evidenza (“chi vola / crede vicino il cielo e pensa il bordo / a qualche colpo d’ala e incide forme / che ricalcano il nulla. E dopo il volo / non ci fu segno che scalfisse il vento”, “Nell’acqua essere gocce su due rive, / essere stati immensi e svaporare / di niente, in grani d’oro”). Svestendo la sua ombra metafisica, il tempo mostra il suo sguardo più feroce, quello dei giorni umani che si lasciano alle spalle le stagioni della vita: “All’improvviso apprendi che l’azzurro / non è quello che fu quand’era azzurra / l’anima. Il cielo che su troppe stelle / è tramontato, non ha più nel vento / certi respiri. / Poi sarà dormire… / ma non è sogno che ritorni ai sensi / quando la coltre è terra e quando sorge / la luce che risplende e non risveglia. // Oggi che troppi volti hanno parvenza, / forme non altro che contorni vaghi, / il pensiero che cerca e che ritenta, / ha solo gocce e inariditi laghi”, mentre “ogni volta sarà sempre più fioco / il ritorno dei volti e delle cose, / fino all’ultimo sboccio delle rose”. La memoria si trova a confrontarsi con età perdute, lacerti di un passato ancora inconsapevole (“c’erano sorsi d’acqua alla ringhiera, / orli di terracotta rinfrescati / e un odore rinato di gerani”) che “si rompeva nelle veglie inquiete / della negata adolescenza”. È il declinare delle illusioni, non dolorose e amare come quelle leopardiane perché seguite da un’esistenza piena, ma comunque filtrate dalla percezione: “C’è sempre un bocciòlo di bugia / che porta e porge / un lume per la notte, / e un vento, che deforma sul lucignolo / la vita fievole. // C’è sempre una candela / che rifiltra / in crepe d’ombra, / e sempre un dito che sfumando il cielo / ritesse il velo”. Il pensiero corre agli anni giovanili, quelli vissuti tra “il timore che teme di svelarsi” e “lo stupore / di apprendere la vita”, quando “il tempo, all’orizzonte, / era profondo, e il vertice lontano” e i giorni erano fatti di “attese vere / all’orlo di una sorte sconosciuta, / gioiose meraviglie senza spettri”, una “effimera stagione / al balenare incredulo dell’ombra, / ancora dissipato dall’ardore”. Quel periodo della vita, in definitiva, nel quale “il seme / ha più forza della terra” e “il fuoco / non sa chinare la fiamma”.
Riguardo alle date di composizione, si nota come si concentrino negli anni a cavallo tra la fine del passato millennio e l’inizio dell’attuale – che sono, poi, le stagioni della composizione di Mythos, di cui questo libro è quindi a maggior ragione l’altra faccia – diradandosi nel decennio successivo e rinvigorendosi in questi anni recenti. Non è irrilevante notare come nel libro non entri praticamente mai la cronaca, se non in un singolo breve testo nel quale si allude alla tragedia dell’11 settembre 2001 e in un altro, recente, che ha la forma dell’invettiva contro questo nostro tempo “del denaro e delle vuote / immagini, dimora dei pensieri / senza intelletto e del barbaro idioma / curvo al dominio e di fierezza spento”, “delle cose mercenarie / e senza pregio, dei valori estinti, / dati all’altare del divino nulla / per cui tutto si elèva”, “delle drogate meraviglie / e dei ciechi giudizi insussistenti / … / dove l’infimo sale e il sommo sconta”, un tempo di rovine nel quale “si usura la stagione dei millenni”. Sono tracce qui minime di altri filoni, ancora inediti, cui Bernabei ha ampiamente atteso in questi anni, dalla satira sul presente alla traduzione oraziana fino ad una centenaria corona di sonetti. S’incontrano poi, a tratti, le orme evidenti – ma al tempo stesso lievi e non invadenti, più che altro omaggi – di alcuni maestri: dalla lezione della poesia amorosa spagnola (“tracce di endecasillabi e di luna / e chitarre smarrite ed occhi persi”, “Un’ora è lunga senza le tue labbra / un’ora è lunga, / un giorno senza il tuo respiro / un giorno è lungo” con quanto segue) ad Ungaretti, del quale abbiamo già fatto cenno, fino agli amatissimi Dante e Leopardi. Il grande fiorentino, di cui Bernabei è tra i più assidui studiosi ed esperti, lo ritroviamo in alcuni passaggi d’impianto metafisico e alta speculazione: “Ma il tempo non rallenta e non ripiega / e guarda all’infinito / che nasconde / il punto che l’orienta e che lo spiega”, “se guardi dove il cielo si confonde, / al fondo dei tuoi occhi già si annida / tutto il flusso che svuota mentre colma, / e già si ferma il tempo, / come attratto / nel suo riflesso, / dentro il tuo specchio / che diventa eterno”, “se fra le dita mi rimane il gioco / d’incastri già risolti e già di sensi / appresi, e il nuovo gioco che distorce / ed altri sensi crea non designati, / e l’universo conosciuto e il passo / ad altri mondi, e tutto il già pensato / ed il pensiero che potrà salpare. / Se fra le mani ho tutto, alle parole, / e mi ritorna il tempo già perduto / e nasce a un tratto un bordo da spiegare”, “giù, dove scende il tempo e non ritorna, / irida, il passo che salendo brilla, / un giorno di freschezza, e si contorna / limpido dello sguardo che scintilla, / innamorando il fragile respiro / al delirante raggio senza giro”, “come il perno che regge non si muove / e guarda il punto come più si affretta / quant’è più largo il cerchio e dista il dove, // così la mente è ferma quando aspetta / che più lontano o meno ruoti il segno / per la cui forma l’anima sia schietta”). Vi sono poi alcuni idilli di attinenza leopardiana, nei quali la malinconia e la disillusione (pur mitigate dalla compostezza del raziocinio) non possono che concentrarsi sul “suono trascorso e suono ancora vivo, / gravido e mesto del tempo percorso” e sulla “voce di nostalgia, voce che illude / se rosseggi il chiarore dove muore / o sciolga l’ombra, e sembri che rinasca”. Trovano qui spazio e collocazione sensazioni d’infanzia e giovinezza, profumi e odori che in modo quasi proustiano riportano alla mente “la spensierata ed indulgente assenza / d’ogni premura, gli orizzonti accesi, / confini blandi tra promesse e voli”: un “sedimento che [si] cancella” nei territori del rimpianto. Fino al passaggio più leopardiano di tutti, quasi una immedesimazione (e forse è il modo migliore di leggere questi idilli, come se il grande recanatese tornasse a parlare attraverso Bernabei): “Quando la mente non avrà più cera / – né congetture né memorie – questo / minimo spazio che concesse il caso / per un avaro tratto di cammino / di lampi e trame e di profondi affetti, / … / che sarà del mio mondo immenso e strano? / del presunto infinito che dilata / ogni frantume come fosse immane? / Perché questa illusione sconfinata / in un’infinitesima misura? / chi disse eterno un tempo che non dura?”. La conclusione è sconsolata: “La luce di un momento e poi l’ignara / assenza, che non ha nemmeno il segno / di quello che conobbe. / Sono lampi le vite, sguardi appena / dentro una notte lacerata e spenta, / la fede pronunciata e già tradita. / Come parvero estese le speranze / e lunghi i sogni, ed ebbero gl’incontri / l’inganno di tornare ad ogni sete!”.
Le poesie più recenti sono intrise di un sentimento della sera, conseguenza anche d’alcuni lutti: a diversi amici, e alla sorella Liana, Bernabei ha dovuto purtroppo dedicare liriche commemorative, commosse e al tempo stesso asciutte e senza alcuna retorica (“Tu che non hai più passo, più non senti / questo tacere del vitale immenso / che sa di note ferme agli strumenti, / pronti comunque ad altre melodie. / … / Frammenti di frammenti quelli andati, / il fiotto che si mosse dalla fonte / e non inverte mai dove propende”). Il dettato rimane limpido ma l’atteggiamento è privo di consolazioni velleitarie: il tempo è trascorso, l’eternità esiste ma è difficile viverla nei giorni (“Ora che langue il tempo / e che si gira, / scorge sfocato, / per estrema fuga, / che fu sognato”, “Il sole può tornare, / ma una sola / volta che scenda / la nostra breve luce, / si stenderà una notte senza fine”, “Pelle senza carezze né ferita, / indifferente / al modo che la sfiori / o che l’affligga, / deserta al senso / dove il senso è muto”, “tanto che il tempo c’è, ma non assiste / e corrompe il pensiero e la certezza / che più non sa se vive o non esiste, / ma che tutto balena e già si spezza”, “Quello che lasci è solo immateriale / pianto di sensi e di pensiero, inerme / desiderio che tenta di protrarre / il lampo irrimediabile e l’istante”). Sembra un panorama di desolazione e forse lo è, deprecando la tarda solitudine che tocca in sorte a molti: “In questo lento perdersi di foglie / e della vita condivisa, quando / a nessuno dirai se si ricordi, / e senza incontro quello che godesti / sarà larva di un sogno alla deriva, / saprai la solitudine funesta, / quella che non ha più scelte in disparte / e se chiede una sosta che accompagni / raccoglie un suono di pareti spoglie”. Versi nei quali né la maestria poetica, né l’elegantissimo gioco di ritmi e di suoni addolciscono l’amarezza dell’idea di fondo. Il tempo appare indifferente al destino umano, l’eternità agognata non trova spazio nelle ore del declino. “Fosti naufragio dolce d’infinito / e soltanto ingannevole lusinga, / come tutto che appare e non si avvera. / … / il vagheggiato immenso / non è che una vorace gola occulta / o l’immane sperone che si abbatte / disgregando ogni cosa”. Ancora: “Sarà di questo modo di sentire, / di queste irreversibili emozioni / viventi, irripetibili, vissute, / che l’universo non avrà dolore / né soffrirà le cieche primavere / che non daranno steli a questi sbocci. / Non si dilegua il rapido cammino / dove non c’è più luce e non c’è l’ombra, / per l’assenza, che tempera l’eterno / e comprende in quel punto il marginale / tempo che fu, senza che fu mai stato; / non si spegne l’abbaglio di un frammento, / ma solo l’indicibile sentire / di un vento che passò, che più non seppe / la foglia che dal nesso fu staccata”. Impossibile, allora, anche prefigurare il dopo, o semplicemente un qualsiasi dopo: “Poco ci resta e non sappiamo quanto / quell’effimero specchio avrà ricordi, / come ci perderemo dentro il mare / dove ogni goccia va perché concordi”. Il mare, quel potenziale specchio da cui abbiamo preso avvio in questa estesa ricognizione, non è neppur esso una risposta, non la rappresenta né la propone, ora che il tempo “ha decantato il sogno e il sogno è frode”.
Ma può forse ancora sussistere un’eternità più minuta, scandita dalle ore: “Ridiscendere il tratto lungo e breve / di ventimila albori e ritrovare / per un prodigio l’angolo perduto / dove balza, ridendo, una passione / che nessun’ora potrà più colmare”. Un’affermazione nella quale, oggettivamente, non si saprebbe dire se prevalga il rimpianto o il piacere di riscoprire ciò che è stato, come suggerisce quel “ridendo”. Ed è poi il poeta a ridere, o la passione? Indefinitezza poetica che, come appunto Leopardi ha insegnato, è tra le caratteristiche più suggestive dell’arte poetica. E dunque il nastro si riavvolge e forse chiude un cerchio: in una poesia della prima parte il poeta diceva “Ridiamo, come il giorno che non torna / o come il tempo che non ha misura / … / come il fiume che non sente / che la corrente inclina ed è lo specchio / di luce senza fasi, che risplende / perché vuole e sempre. / Come bronzo sciolto / che non distingue il suono della festa / e canta perché canta, e il canto resta”. Alla mestizia si oppone l’allegria, “il verso del mattino che risponde / al verso” con la spontaneità, la meraviglia, l’abbandono: “la parola che viene / come viene. / Non chiedere perché! / Vivi di suono e di cadenza, / godi l’essenza d’incontri nuovi”. Ancora: “Spiega / la vista acuta delle fiabe, immergi / l’anima, ad occhi chiusi, di un pennello / fatato nei colori dell’istinto / e la concava tela alle pupille / si svela in infinite angolature, / fondali al sogno”. È vero, sono parole di vent’anni addietro, ma è in questo libro che trovano collocazione. Così, se appare impotente anche la “caduca intelligenza / che pensò di sapere” e “fruga per anse / dove un nulla dica / qualcosa della vita”, rimane almeno la possibilità felice della gratitudine, quella che Bernabei esprime ai propri genitori e con la quale suggella l’intero vetro di Narciso. Una lirica all’apparenza semplice e piana, ma che riassume e concatena moltissimi motivi e concetti-chiave presenti nel libro: la ricerca e il mistero, l’incontro, il valore e il senso (e sapore) della vita, la fioritura e il nutrimento, il dono e le attese, il “mio ritaglio di terra” e “i retaggi del sangue / per cui ebbi note e parole / e l’estro di cantarle”, e infine “grazie per l’àncora e per l’ansa / dove ormeggiai sicuri / gli anni del tempo fragile / e preservai le vele e il legno, / mentre appresi il timone per le rotte / di solitudine. // Grazie perché tornate, / sia pure per assenza, / nel pensiero, / e del passato riportate almeno / la nostalgia”. La vita, forse, è più semplice e lineare del nostro interrogarla e interrogarci. Una conclusione che illumina un libro già di per sé luminoso e al quale manca, in realtà, appena un estremo tassello. C’è infatti una dedica finale che avrebbe potuto aprire la raccolta e invece la chiude, con tanto di firma autografa, quasi a farne una disposizione (idealmente) definitiva: “Per tutte le sperate / umane eternità”, a dirci tre cose e ciascuna importante quanto le altre. Innanzitutto che l’eternità non è una certezza bensì una speranza, poi che non si trova al di fuori di noi (né del tempo) ma appartiene alla natura e alla condizione umana, infine che non è unica e uguale per tutti: “le” eternità, non “la” eternità. Poche parole che, con il bagliore di un lampo, sfaccettano e moltiplicano tutti i temi del libro, in un riverbero incontrollato: frammenti di quel vetro o, forse, lo stupore di un destino irriducibile, quella – per dirlo con un altro suo verso – “forma che scavi nello spazio / ed è più nuova / ad ogni gesto”. Precisamente come l’autentica poesia, come questa poesia.
Stefano Valentini
Padova, luglio 2020
Ho centellinato le poesie della raccolta. Sono poesie fatte di parole lievi, evanescenti, che hanno la leggerezza dei suoni puri, quasi deprivati di materialità: emozioni, ricordi, ombre, sogni, colorazioni, parole che dicono di un tempo che viene ed è già finito, eppure è vita, vita al limite dell’esistere, che si proietta in un divenire impalpabile, fatto di sensazioni e di ascolti dell’anima, del profondo respiro del mondo. Narciso, scoprendo se stesso, scopre l’anello che lo collega all’altro da sé, un mondo caduco, e non meno affascinante, fissato dall’autore nella bellezza della poesia.
Tornerò a rileggerle, perché ho ancora molto da approfondire.
Piergiorgio Boscariol





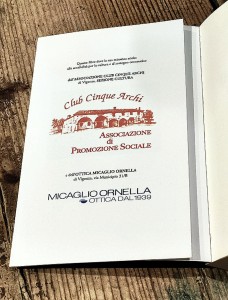


*

To prove that you're not a bot, enter this code