Sinopsi di Jorge Amado, in copia originale
Prefazione di Elio Pecora alla silloge L’errore del tempo
L’urgenza di scrivere (per di più di scrivere in versi, di tentare la poesia che è allo stesso tempo, visione-emozione-confidenza) nasce certo dalla scontentezza. Nell’Eden la creatura sta, non giudica, non confronta, non desidera. Invece, nella vicenda terrena, l’uomo fin dai suoi primi anni va immaginandosi un’armonia ed un bene che subito gli si presentano impossibili. La nostra è una storia di fatiche, di divieti, di attese interminabili e sempre deluse. Pure ciascuno si porta dentro, venuta chi sa da dove, radicata nella memoria e nel cuore, una promessa di totale definitiva felicità. Contro una simile promessa va scontrandosi quel che la quotidianità porta, ripete, consuma. Dunque la brevità della vita, la precarietà di ogni bene, la fragilità di ogni amore, la presenza ininterrotta del dolore, la minaccia costante del morire.
Il poeta però, o colui che accosta la poesia e la tenta, s’oppone a tutto questo ricreando e ripetendo l’essere nel suo farsi e disfarsi, nella sua ebbrezza, nella sua verità. Tanto accade nei componimenti di Amato Maria Bernabei, che fluiscono dentro strofe folte e brevi, a volte in prolungate elencazioni, in accese evocazioni, per versi ora veloci, ora trattenuti, dentro rime ed assonanze, e in una lingua che quasi mai s’allontana dalla nostra tradizione poetica, ma che si lascia, senza infingimenti e senza pudori, alla preghiera, alla riflessione, alla visione ferma e malinconica.
Ed è proprio la malinconia, come sentimento estenuante ed avvolgente ed estremo, a muovere gran parte di queste pagine. Ché tutto della giornata umana, e di quel che ci spetta e ci attende, porta qui a domande ultime, amare e sospese.
Così l’amore, che pone fra gli amanti un muro invalicabile; così il tempo che avvolge e consuma ogni cosa (“…le cose immerse / in questo fiume misterioso / che ha sempre acqua, / e mai le stesse gocce”); così il sogno che si confonde alla veglia (“Mi dissero che il sogno / non ha senso, / ma qual è il senso / del non-sogno?”).
Dietro tanta sconsolatezza troviamo però un’attenzione amorosissima verso quel che ci circonda e comprende. Molte volte appaiono qui alberi e cieli ed acque, vi mutano stagioni, vi passano le ore della luce e dell’ombra. Perciò la solitudine, di chi ha provato la sua voce ed è arrivato ad esprimersi con gli strumenti della poesia, finalmente si stempra nella visione di una realtà più estesa e colma. Perciò, anche stavolta, la parola si libra per divenire canto, che un poco dà compagnia e un poco consola.
Elio Pecora
Roma, Ottobre 1989
Recensione di Roberto Carifi
comparsa sulla rivista “Poesia” (Crocetti Editore – MI)
Anno IV – Novembre 1991 – N. 5
Per competenza, a cura di Roberto Carifi
Anche per Bernabei la poesia appare una speranza, una parola su cui scommettere nel grande errore di questa epoca. Elio Pecora, nella prefazione al volume (“L’Errore del tempo”, dal Canto d’amore e di morte) parla di “una lingua che quasi mai si allontana dalla nostra tradizione poetica, ma che si lascia, senza infingimenti e senza pudori, alla preghiera, alla riflessione, alla visione ferma e malinconica“. Osservazioni preziose che aiutano nella lettura di un poeta che attinge alla tradizione con dignità, con una voce sommessa e autenticamente forte.
Recensione di Sandro Bernabei alla silloge L’errore del tempo
Il recupero sistematico di una fede singolare sembra risolvere l’indagine interpretativa de “L’errore del tempo” di Amato Maria Bernabei. La genesi poetica muove da una pressante necessità esistenziale, instabile nei percorsi consueti, alla costante ricerca di elementi con cui poter confrontare percezioni originali. Ne consegue una sorta di raffronto dialettico tra le intuizioni del poeta e i percorsi alternativi della realtà.
In questo universo sperimentale non vi sono certezze assolute; i sogni, le illusioni, il destino, le angosce non definiscono parametri immutabili, simboli di un vivere predeterminato. Viene messo in discussione quanto di inevitabile è presente nell’avventura umana, non per ispirazione divina, ma come percettibile sensazione di un sopra-naturale che dal dubbio origina, trae motivo di essere.
“Se io fossi un sogno,
se tu fossi un sogno,
che cosa sarebbe
questo ripetersi strano
delle sere
e dei mattini?”
E tuttavia il dubbio non consolida le impressioni, anzi spesso turba, confonde, sconvolge; lo smarrimento disintonizza dal canto della natura, riesce a sopravanzare il possibile; la realtà propone altri criteri, altre valutazioni, altri confini.
Questa apparente dissonanza trova equilibrio nell’uso misurato di un compromesso che non dissolva l’essenza del mistero, ma che all’un tempo eluda tentativi di verifica.
”Così sarò sempre un funambolo
agile e barcollante
sui confini della verità.”
L’ambigua, illusiva immagine non approda all’inganno, si afferma al contrario come unico dettato poetico e umano capace di sovvertire lo statu quo, germina i presupposti di una revisione che muti i paradigmi del problema, identifica nella poesia l’elemento vivificante le aride elucubrazioni filosofiche, atto a mediare l’infinito e il compromesso.
L’analisi speculativa addita sentieri rischiosi, conferma l’amarezza del quotidiano, conduce inevitabilmente sul “proscenio illuminato” dove
“qualunque sia la parte
la commedia è segnata.”
La poesia restituisce all’uomo una possibilità per spezzare l’incessante ripetersi del ciclo, offre mezzi idonei ad un recupero emotivo che orienti nel “dissonante accento” verso la “LUCE”. Che è ipotesi metafisica ma anche antitesi di oscurità, elemento della notte: ricorrente, costante forza gravitazionale, fattore dominante l’esperienza sensibile, immagine inquietante del mistero.
Di nuovo e di volta in volta si genera il dissidio duale, quasi una contraddizione in termini, certamente non sostanziale; ma che assume toni sconcertanti nella stessa discordante visione della LUCE: “errore del tempo senza fine” e strumento salvifico.
All’interno di questa radicale insofferenza si delineano, maturano e vengono alla luce i tratti di una riproposizione strutturale dell’essere e del divenire che aprono alla speranza, ancora latente, ma che armonizza l’equazione poeta = evasione dal reale = fede. La “disordinata fantasia” del poeta parados salmente redime.
Acquista in tal modo chiarezza la dialettica degli opposti: serenità ed angoscia, luce ed ombra, illusione e realtà convergono entro un ambito di più contenuta enfatizzazione ma di straripante intimismo. La dicotomia riduce i contrasti, flette ad una misura conciliante, orienta le energie ad un fine che non fonde i due termini, ma li plasma in una conditio sui generis in cui il conflitto muta in comune orientamento tendente alla dimostrazione dell’enunciato.
“Vivere è più bello
e più terribile
di quello che sappiamo.”
“Bello” e “terribile” assurgono a emblema di quella tolleranza, diventano sintesi della ricerca, evocano suggestioni di una realtà esterna alla norma; l’animo turbato del poeta naufraga in “incontenibili malinconie”. Nelle quali la tempesta dei sensi gradualmente dissolve; nascono liriche raffinate, discrete, quasi confessioni esclusive (“Scrivo / per stare con me”), permeate di tenerezza, dove il grido è anelito, non disperazione; il silenzio è meditazione, non assenza.
Purificanti attimi di quiete relegano la realtà in un’attesa indefinita. L’ansia per la sera che sopraggiunge ripropone nella sua drammaticità il senso razionale dell’esistere; rifiuta gli equivoci significati della convenzione umana, genitrice di subdoli obiettivi; non sopporta la fisicità del tempo, peraltro tangibile solo nel mutato aspetto, nei “fiori caduti che non cogliemmo”, nel “cielo di platani” che “ingiallisce”; rimpiange gli istanti senza tempo dell’amore tanto intensi quanto fuggenti e perciò gravidi di nostalgia; assoluti, segreti, effimeri e perciò irripetibili.
L’amore è comunque un attimo di quiete; come il ricordo, come il rapporto con la natura.
Il ricordo sfuma in soffuse dinamiche emozionali: non scatena il pianto, si allontana confinando fantasmi di angoscia in una catarsi espressiva dai toni stemperati, evocanti finalità che infrangano la consolidata prassi esistenziale.
Il dialogo con la natura si fa incessante, necessario, imprescindibile; si affollano sussurri e acuti e fruscii, e ancora emozioni e suoni e colori: la pioggia, il vento, fossati e fontane, “verdi trasparenti”, l’azzurro che il “cielo lentamente distilla”, incanti di primavera; e la materia diventa Poesia. Autentica, per libertà di ispirazione, per il suo respiro elegiaco, per la sua coralità. Una poesia che affresca con un linguaggio ampio di cromatismi sapienti, libero, di immagini immediate, esemplare nelle linee essenziali, che chiede alla musica il giusto compenso.
Non c’è il melos del genio, ma l’armonia costruisce architetture di classica compostezza, di elegante equilibrio strumentale. Gli accenti ritmici dalle ineguali, imprevedibili combinazioni, dosano masse armoniche in organici insiemi orchestrali, sicché la resa sonora non deriva dall’uso ricercato, ossessivo di parole-suono, ma da andamenti timbrici globali.
La poesia si fa canto; e il canto libera i confini del tempo, rompe “l’argine del tramonto” quando “l’altalena delle voci / nella sala si spegne”, trova, nel suo stesso essere, respiro metafisico alieno da preconcetti, da vincoli pragmatici, da presupposti divini:
“…confiderò
che resti il segno del mio canto.”
L’ombra frantumerà l’unicum filosofico-espressivo-armonico in fragili abbandoni ad un esistere perverso che gioca sull’ambiguità di una “fede / penetrante e vana” che tradisce il segreto e lo traduce in illusione.
Ma l’approccio all’eterno non tarderà a disperdere l’effimero nei meandri del tempo; muterà i parametri della fede allo sgomento esistenziale.
”Se vivere è soltanto
un prezzo da pagare
se questa tristezza
anche dolce
è un preludio,
è solo un barlume
di LUCE,
amo questa vicenda di colori
che si spaventa nel tramonto
e si confonde.”
Sandro Bernabei
Dicembre 1991
Recensione di Maria Luisa Biancotto
Come la gemma sul ramo di febbraio annuncia della pianta l’imminente rigogliosa fioritura, così, il piccolo libro di poesie d’amore, Dove declina il sole, di Amato Maria Bernabei edito dalla Libroitaliano internazionale di Ragusa che sarà presentato il 19 febbraio, ore 21, all’Auditoriurn Comunale di piazza Zanella, a Vigonza (PD), dalla critica letteraria Grazia Giordano, porta alla luce l’esistenza di un autore di grande talento e levatura rimasto finora pressoché sconosciuto, ma destinato a lasciare con la qualità dei suoi versi e il tesoro di poesie accumulato, una traccia profonda nella poesia italiana. Amato Bernabei è di origine abruzzese; dopo la laurea in Lettere, a Chieti, nel ‘70 si è trasferito nel Veneto, per amore di una donna padovana, che ha sposato e da cui ha avuto una figlia. Alla città ha preferito il silenzio della campagna di Peraga, vive in un’antica casa rurale, in via Paradisi, – “il Signore della torre”, lo chiamano in paese. Persona eclettica, affianca all’amore per la poesia, la passione per la musica, la grafica computerizzata, il videomontaggio, e l’ipnosi a scopo terapeutico e per potenziare l’attenzione nei ragazzi. Dopo anni d’insegnamento, ha scelto di dedicarsi completamente alla sua vocazione, e assecondando la Musa ispiratrice, sciogliere nel verso limpido e felice, di classica matrice, a lui congeniale, il demone inquieto che nutre il suo fuoco esistenziale. Sfida il tempo, tenta l’indicibile la parola che nel suo verso si fa canto. Lirica, elegiaca, la sua poesia è un impegno perseguito con fede, la ragione e il senso di tutta una vita. Ha pubblicato nel ‘90 una prima raccolta di poesie: L’errore del tempo, con prefazione di Elio Pecora e una sinopsi di Jorge Amado. Nel ‘93 alcune sue liriche inedite sono state incluse nel Catalogo del I Premio Teaterno, nel ‘97 ha risposto per curiosità a un’inserzione della Libroitaliano su “Repubblica”, che cercava una decina di opere poetiche da pubblicare nel corso dell’anno. Ne è uscita la raccolta di cui sopra, come Premio selezione poesia ‘97”. Ma escluse le esercitazioni giovanili, sono varie centinaia le poesie composte e raccolte dal ‘72 ad oggi, oltre a tre poemetti, un dramma in due atti, “L’inganno”, e un romanzo, “Lo specchio”, in attesa di edizione. “Credo che un poeta possa scrivere un solo libro nella sua vita, i titoli sono solo un’esigenza tipografica”. “La conoscenza della musica e la predisposizione naturale per la lirica mi rendono facile il verseggiare. In endecasillabi e novenari già a 12 anni improvvisavo composizioni sugli spunti più vari che la vita scolastica mi offriva, croce e delizia dei miei professori, che credevano mi distraessi dalle lezioni. Innamorato dei lirici greci e latini, dei classici che ho studiato davvero, mandarli a memoria mi veniva spontaneo, e imitarli un gioco leggero. Questa classicità mi è stata sempre riconosciuta. Irrinunciabile lo scrivere, allora come ora” – Cos’è, per Lei, la poesia? “È fede che aiuta l’uomo a sopravvivere, una sorta di illusione foscoliana; è emozione che si fa parola, che genera a sua volta emozione, in un crescendo esplosivo.” – E l’amore? “È il bello estetico, un valore universale. È l’approdo a qualcosa che non ci appartiene. Forse l’artista non s’innamora di nessuno; come Dio, crea a sua immagine e somiglianza. Come filtro io creo la donna, anche quella che non c’è.”- Le donne? “Le poesie nascono per le donne più disparate, figure anche colte per caso, che mi rimandano qualcosa del bello ideale… Non c’è tradimento, perché è sempre una stessa figura”. – Per chi scrive il poeta? “Scrivo per stare con me. Ho forti dubbi sulla possibilità di comunicare. (“…se parli.. c’è sempre una corteccia / che scalfisci e non varchi. / Nessuno ti ascolta / e può sembrare ìntento… / c’è sempre il guscio tra la noce ed il vento”). Confido… “che resti per qualcuno / un esile segno del mio canto.” – Perché il metro classico le è cosi congeniale? “Forse perché il mio temperamento ha anche bisogno di una regola, e trova nel verso fisso il limite che dà forza e tensione” – Il segreto della sua giovinezza? “Forse proprio la scrittura, l’amore per la vita che diventa forza d’urto contro la morte, e le sue forme quotidiane. È questo per me un momento molto positivo, potente sotto ogni profilo. Ho anche cominciato una vita pubblica: faccio parte di una lista civica di Vigonza, e del Comitato ristretto del Gruppo Atlante Italia 2000, che si propone di rifomare lo stato attraverso 24 progetti”.
Maria Luisa Biancotto
Recensione di Grazia Giordani
Quando ci si appresta ad esprimere giudizi critici e ad operare una analisi estetica di produzione artistica, non si volge l’attenzione soltanto all’opera ultima dell’autore – a quello che per ora è il suo punto d’arrivo -, ma il cammino va considerato nel suo divenire e nel suo evolversi.
Innanzi tutto chi è Amato Maria Bernabei? Quali sono i suoi gusti, le sue inclinazioni? Perché scrive poesie?
A questo ultimo interrogativo sarà l’autore stesso a dare risposta, ma un ritratto interiore del suo personaggio e della sua formazione culturale già lo possiamo tracciare, anche in parte confortati dalla sua poesia. Abruzzese d’origine e padovano d’adozione, non ci è difficile credere alla sua attività di musicista, oltre che di insegnante, frequentatore della pagina dei classici ed incline alla musica, campo in cui insegna e compone. La sua dimestichezza con le humanae litterae balza agli occhi del lettore per i frequenti richiami classici e la finezza del lessico, per il gusto sottile della metafora, della similitudine e di quei giochi retorici che sottolineano un certo tipo di formazione culturale; la sua capacità di destreggiarsi fra le note, è posta in risalto dal canto che sgorga dal suo verseggiare, una musicalità, un mélos che gli deriva dal suo saper scrivere anche sul pentagramma.
A proposito del Canto d’amore e di morte, titolo complessivo dell’opera omnia di Amato Maria Bernabei, è opportuno partire dalla sua prima silloge, L’errore del tempo, prefato da Elio Pecora che sottolinea – fra l’altro – nel poeta, la fragilità dell’umano sentire, la presenza del dolore, la costante di Eros kaì Thanatos, la poetica endiadi di Amore e Morte, tema forte dell’impegno lirico dell’autore.
La bella penna di Jorge Amado ha onorato la poesia del Nostro, parlando di «linguaggio ornato, di greca trasparenza», creando quasi un aforisma pregnante dei valori semantici ed estetici della capacità espressiva di Bernabei.
Poesie d’amore, dicevamo, intessute da una malinconia sottile, che non è uno spleen baudelairiano, non un sentimento morboso, ma sembra nascere – anche se siamo lungi dal voler entrare nel vissuto del poeta -, da reali esperienze di vita: (Scroscia sull’anima cieca la del tempo, e tramonta./ C’è sempre/una sera…/ Per i tuoi occhi neri / notte di stelle spente) E più oltre a p.17 e quindi L’angoscia esistenziale / è amore per la vita, come a dire che soffrire è vivere amando; e ancora Morirà questa stagione / come tutte le cose che vivono / così ardentemente / come tutte le cose immerse / in questo fiume misterioso. E ancora: Ho visto morire; è certo / che qualcosa di noi morirà E per finire con gli esempi tratti dal primo florilegio: Così l’amore / si romperà: il caleidoscopio impazzito / non ricomporrà più baci / e l’orizzonte cieco inghiottirà / labbra, carezze, rose. La silloge ultima dell’autore – Dove declina il sole – pubblicata nella terra di Quasimodo e di Lucio Piccolo, prefata da Salvatore Fava che pone in luce anche «l’idea della vita visualizzata», alla maniera degli acmeisti russi – contrapposti ai simbolisti, aggiungerei io, esaminando l’opera – continua il tema di Amore e Morte, ma non è tautologica rispetto alle liriche precedenti, poiché Bernabei è “cresciuto”, nel frattempo è maturato, prendendo consapevolezza del suo “cercare il sogno”, consapevolmente cerca l’illusione, sa ora che la realtà non è questa; sa che gli amori finiscono, come l’umano esistere si consuma, ma cerca l’aspetto onirico dell’amore, quello sognato: E forse tu sarai l’ultimo sogno/ l’ultima fiaba che io mi racconto.
Resta il tema del pànta rei, del tempo che scorre inesorabile e tutto consuma: Il tempo se ne va, se ne va / e il tuo viso di aurora non è tra le mie mani / ma chi mi ridarà queste ore / di desiderio smentito, / questa sabbia rovente che frana in una gola di clessidra? Ma il poeta, dopotutto, non sembra essere disperato, in lui è subentrato un ellenico fatalismo, la frequentazione con i lirici del mondo classico, sembra avergli regalato una rassegnazione che non è quiescenza, che non è abulica rinuncia, ma presa di coscienza che nulla si può contro la Moira e l’anànke.
Il contenuto filosofico-esistenziale può richiamarci Leopardi che l’autore cita quasi di proposito con molteplici accenni alla “luna”, una luna ambigua, che è quasi una vox media, ora positiva, ora negativa, nella visione filosofica del poeta: (… germoglierà da un desiderio ardito / -fiore che nasce nel rigido inverno -/ questo canto alla Luna; Venisti quando ancora nell’acerba / luce filtra la vena della sera / quando l’estate di novembre teme / lo sguardo delle nebbie, meridiana Luna smarrita. La tua voce antica / avevo colto come una preghiera / un richiamo per vivere…; Così tra i boschi vaga tormentosa / un’angoscia di tenebre, aggredita / dal ramo che si spezza o dall’ambigua / carezza di un notturno vento, morsa / da un grido sordo o da un frullo di ali, / prima che da uno scoglio di montagne / la stemperi la Luna che si sporge; Nell’eclisse che vela e non cancella / non muore il desiderio della Luna / che porgeva le labbra e le ritrasse / che soffocò la luce e l’emozione / e si negò uno spazio per brillare / nel segno dell’ottusa convenzione; …alla corrente, dentro l’ombra in fuga / che forse si spegneva con la luna; C’è una stagione che deforma appena / la luna / quando la sera affaccia / all’orlo di un bicchiere d’erba / l’anima; Non sveglierò la luna / voglio vedere stelle / ad una ad una / cadere dai tuoi occhi; Come guardo la luna / e l’abisso che la contiene / è oltre / come c’è soltanto la luna. A questo punto sarebbe interessante chiedere all’autore la ragione per cui “luna” appare scritto ora con la maiuscola, e ora no. Un capriccio del poeta? Una pregnanza particolare?
Ad abitare la pagina lirica di Bernabei non c’è solo il pallido astro, ma anche il tema dell’assenza e soprattutto quello del sogno: E forse tu sarai l’ultimo sogno, / l’ultima fiaba che io mi racconto – avevamo più sopra rilevato, e ancora: Per me cade il sipario sui derisi / sogni, per te dopo la sera c’è un ritorno; forse la Primavera non concede / lo spazio al sogno e il tempo di volare; Non canta l’usignolo / e disorienta l’anima che cerca / lo spazio al volo e il tempo di sognare; …tu mi porti nel leggero / passo degli anni il trasparente argento / dei sogni e fiotti del tuo riso vero; Ed io vivo,/ almeno come il sogno di esserci; Ti aspetterò sull’orizzonte, al bordo / del tuo sogno di alabastro; L’assenza del tuo viso torce il tempo / in labirinti senza sbocchi / il senso della luce / è nei tuoi occhi, e la vita / non è questo vuoto / allungarsi delle ore / e la fuga del cielo dentro i sogni; ma il sogno non ripaga il desiderio / e non riempie il giorno, anzi lo strema / dentro la molle traccia / del ricordo; Mi basteranno tutte le parole / che mi sussurri al bordo della sera / e l’altalena lenta di viole / che dondola tra un sogno e una preghiera; Non c’è che il sogno, bambina / dentro lo spazio stretto / di questa vita / e vivere dormendo è come / non svegliarsi mai / per non morire; meglio la notte / meglio gli occhi chiusi / sui vortici dell’ombra / e bere il sogno all’anfora che gira i fili bianchi della luna.
Il linguaggio immaginifico di Bernabei ci fa capire quanto l’autore abbia amato il suo conterraneo D’Annunzio, che avrebbe approvato la sua aristocrazia del lessico. E quanto abbia amato anche Ungaretti che io ritengo essere uno dei suoi maestri ideali.
Un’analisi quantitativa e semantica – nel senso etimologico di significato del linguaggio – ci porta a sottolineare come il vocabolario del poeta si colori di espressioni cromatiche (La vita scoppia in fuoco d’illusione; io non sono al poggiolo che si affaccia / sul verde sterminato del lontano; guardo un cristallo senza desiderio / di gocce azzurre strette da un nevaio, ecc.) meno vivide che nella raccolta precedente in cui si parlava di sangue, della fiammata ardente dei papaveri, ecc. Alla maturazione sentimentale del poeta che capisce l’importanza di sognare per cui – anche se «il sogno non ripaga il desiderio», è pur sempre un surrogato di quella realtà che a nessuno di noi è dato vivere in una ideale pienezza – sembra corrispondere una pacatezza nel colore espressivo, quasi che la tavolozza dell’artista si sia smorzata, non per intensità espressiva, ma per raccolto sentimento interiore.
Bernabei ha ancora, poeticamente parlando, molta ansia di vita, Seneca con il suo «Protinus vive!» e Orazio con il suo «Carpe diem» lo esortano, come direbbe Ronsard a cogliere fin d’ora «les roses de la vie». Insomma il nostro poeta è “ondivago”, sbattuto dentro un’alternanza di delusione e forza combattiva, com’è giusto che sia un artista, un creativo, un uomo che sa ascoltare la voce del vento, la musica iperurania della luna e che sa scrivere che: «Sotto le ali del gabbiano / in questo mare senza passione / è questa nostra passione / il mare».
Grazia Giordani
Auditorium Comunale di Vigonza
19 Febbraio 1999
* * * * * * *
Il tuo modo di scrivere è, prima di tutto, sofisticato, ma (soprattutto) rievocativo. Le parole che usi, e il modo in cui le fondi tra di loro, lasciano una fantastica sensazione nel lettore (come un retrogusto dolce).
Un lettore (Davide Sasso)
27 Febbraio 2014
Alcune recensioni apparse sui quotidiani

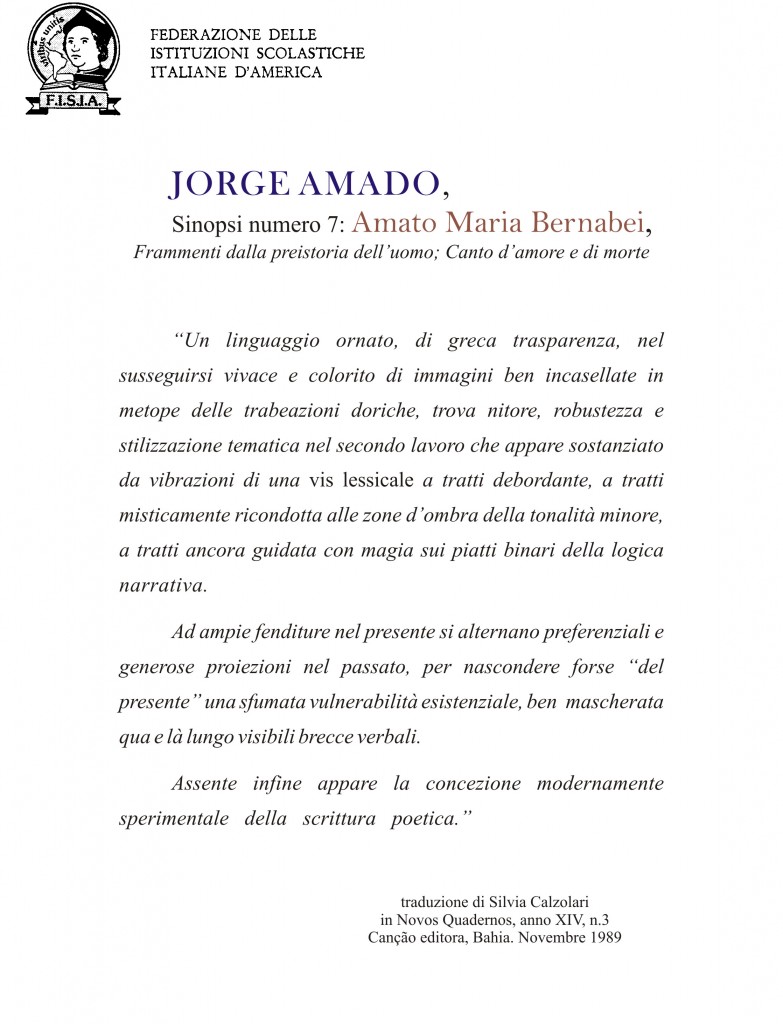

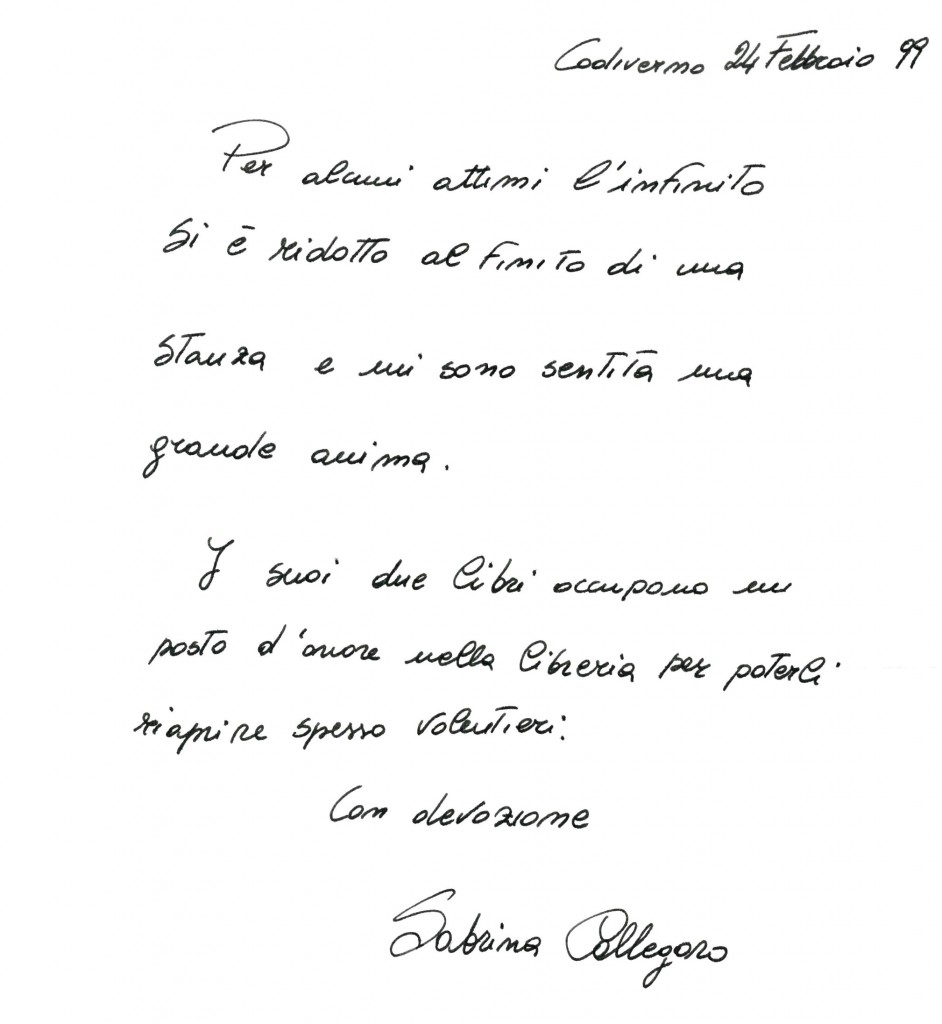




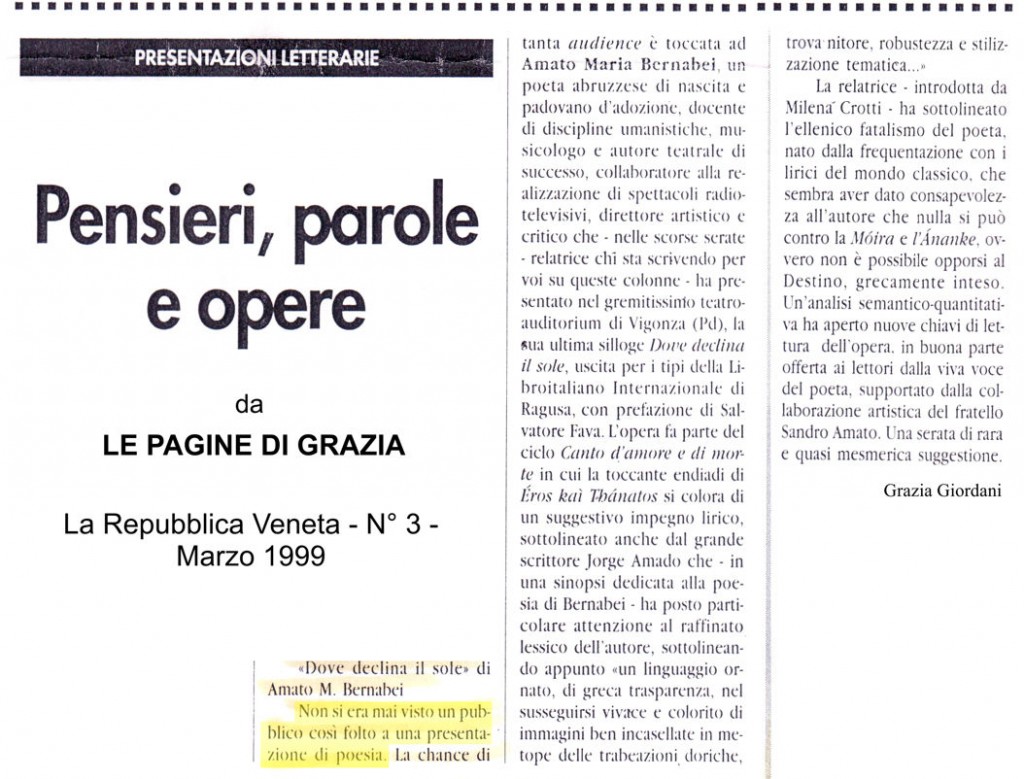
*

To prove that you're not a bot, enter this code