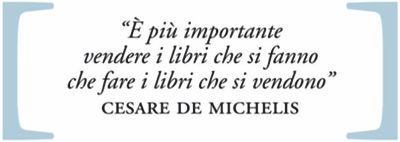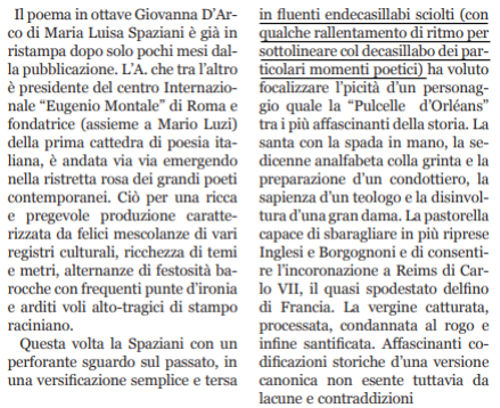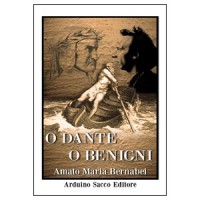A PROPOSITO DI RELATIVISMO
La legittima pluralità di posizioni ha ceduto il posto a un indifferenziato pluralismo,
fondato sull’assunto che tutte le posizioni si equivalgono
(Karol Wojtyla, Fides et ratio, 88)
Quando la ragione non è ricondotta alle proprie profondità
dall’intuizione dell’essere o dall’esperienza del mondo interiore,
essa si trastulla nei sensi e tra i fantasmi,
senza nemmeno rendersi conto che ne è prigioniera
(Jacques Maritain, La filosofia morale, p. 16)
Per una società affetta da Infodemìa esistono solo verità soggettive
(Maurizio Muraca, TEDxAsiago)[1]
 L’assoluto è una qualità intrinseca, che non è soggetta al giudizio, alla valutazione di chi esperisce: che l’acqua è acqua è un assoluto.
L’assoluto è una qualità intrinseca, che non è soggetta al giudizio, alla valutazione di chi esperisce: che l’acqua è acqua è un assoluto.
Il relativo è soggetto al giudizio, alla valutazione di chi esperisce: così qualcosa può piacere o non piacere, indipendentemente dalla sua intrinseca qualità di bello o brutto, giusto o iniquo.
Il relativismo (tutto è relativo) è l’assolutizzazione di un relativo che non può essere assunto come presupposto di ogni realtà.
La Realtà è assoluta (e coincide con il Principio Primo), le realtà sono relative, ristrette ai loro specifici ambiti.
L’essere può esprimere assolutezza, ma anche relatività.
Senza parte nominale e senza complementi è assoluto, riferibile soltanto – che esista o non esista – all’Essere, o Principio Primo, o Realtà (L’Essere metafisico, che perennemente È). Quando esprime temporaneità, l’essere non copulativo può avere solo il significato relativo alla durata limitata del vivere (in senso lato riferito anche al terzo regno), mai di “essere” (l’Essere metafisico non “vive” semplicemente, È, l’essere temporaneo non È, semplicemente vive); oppure indicare uno stato, una condizione, quando sia legato a un complemento (essere in, tra, a, trovarsi…). L’essere copulativo è invece “essere qualcosa” o “avere una qualità” (essere medico, essere grande).
L’esperienza non è riducibile a una categoria singola, non può pretendere di porre un assoluto senza i relativi e un relativo senza GLI assoluti.
Si può concepire UN Assoluto-assoluto accanto ad una molteplicità di assoluti-relativi (attinenti cioè a concetti specifici) e di relativi-assoluti (ovvero assolutamente relativi).
Il Principio Primo è l’Assoluto-assoluto.
Il bello, il brutto, il giusto, l’ingiusto e simili sono Assoluti-relativi (correlati ai rispettivi ambiti di bellezza, bruttezza, giustizia, ingiustizia et similia, frutto delle generalizzazioni scaturite dall’umana esperienza, codificatesi come archetipi nell’inconscio e geneticamente trasmesse).
Va da sé che in contesti diversi la generalizzazione-sintesi può avere espressioni dissimili, anche contrastanti, che tuttavia confermano il senso della parola astratta. Perché la forma verbale unitaria (astrazione sintetica) compendia la natura generale, non le manifestazioni particolari che ne derivano. A un cannibale può sembrare giusto mangiare un proprio simile, a chi non è antropofago no. La parola giusto conserva tuttavia, nei due casi, lo stesso significato di adesione a determinate regole che determinano quanto è lecito o no, differenti nei vari “insiemi” che le stabiliscono e le adottano, e di applicazione delle medesime. Giusto deriva infatti dal latino ius iuris, che indica il “diritto”, il quale altro non è, propriamente, che un «complesso di norme imposte con provvedimenti espressi o vigenti per consuetudine, sulle quali si fondano i rapporti tra i membri di una comunità o si definiscono quelli tra comunità estranee»[2]. Per estensione il concetto vale poi in altri ambiti, magari etici, estetici, religiosi, sportivi e via dicendo.
Ciò che piace e ciò che dispiace, ed affini, sono relativi-assoluti (o assolutamente relativi, se si preferisce), perché dipendenti dal giudizio del singolo che esperisce.
Non è plausibile che sia bello ciò che piace, perché il bello è un assoluto-relativo, il piacere una valutazione soggettiva di un’esperienza: il bello è un essere, il piacere un sembrare (una valutazione).
Gli assoluti-relativi hanno fondamento nell’esperienza e nel bagaglio genetico umano (archetipi), e più pregnanza acquistano in rapporto all’evoluzione individuale.
È opportuno chiarire che quando parlo del concetto di assoluto-relativo intendo l’insieme delle generalizzazioni, delle convenzioni, delle norme, dei criteri, assunti come riferimenti gnoseologici e valori necessari ed “universali” (non metafisici, ma ristretti ad un insieme umano – o comunque ad esso simile – a partire dal più generico, l’umanità)…
Senza l’assoluto-relativo si rende impossibile ogni forma di comunicazione ed ogni enunciato risulta privo di fondamento e di sostanza conoscitiva e comunicativa (gli aggettivi qualificativi sarebbero ad esempio inutilizzabili: il grado comparativo stesso dice della precarietà della qualità, valida in relazione al contesto; una formica è piccola se il termine di paragone è l’elefante, grande se confrontata con un granello di sabbia… ma se per convenzione il parametro di riferimento è l’uomo, piccolo, come assoluto-relativo, è riferibile alla formica e al granello di sabbia!).
¿Non si potrebbe parlare, in tal senso, di una sorta di Giudizio sintetico a priori? ovvero di una «Forma a priori del soggetto pensante» dipendente da attività trascendentale?[3] Per Kant il Giudizio sintetico a priori è costituito da un contenuto a posteriori che deriva dalle impressioni sensibili, e da un elemento a priori, la forma. Il contenuto di tale giudizio deriva perciò dall’esperienza, ma presenta contemporaneamente un carattere universale e necessario, visto che la sintesi dei dati emersi dall’esperienza avviene secondo il modo di funzionare della mente umana.
In relazione a questa interpretazione (quella che cioè si basa sul concetto di assoluto-relativo) si può dichiarare che:
- l’assoluto (ab-solutus) è ciò che è in ogni particolare
- l’assoluto è tutto non essendo niente
- l’assoluto è idea, il particolare è concretezza
- l’assoluto è potenza, il particolare è atto
- l’assoluto è libertà, da qualsiasi vincolo, di qualsiasi incarnazione, il particolare è necessità, dunque prigionia: non può essere diverso da se stesso
- l’assoluto è sintesi, il particolare essenza
- l’assoluto è referente, il particolare è riferito, ascritto.
Al “sapere di non sapere” socratico, il relativismo pare contrapporre l’ognuno SA quello che gli sembra, una sorta di negazione pirandelliana della conoscenza, se non fosse per il fatto che il “parere” soggettivo assurge ora a forma di conoscenza, moltiplicando gli assunti plausibili in una “Babele del vero” che impedisce qualunque forma di condiviso riferimento: come comunicheranno fra loro mille soggetti con mille differenti verità concernenti i medesimi “oggetti”?
Mi torna in mente un passo del mio manuale di filosofia, usato nel primo anno del triennio liceale, e che da quel libro riesumo:
«Il concetto è trama di rapporti fissi, permanenti, intelligibili tra dati sensoriali contingenti e mutevoli. I casi di ingiustizia o ingiustizia sono infiniti e infinitamente varii: ma che cosa è giustizia o ingiustizia, cioè il concetto di giustizia e ingiustizia che troviamo in tutti quei casi, è uno solo e sempre lo stesso. Il concetto è legge secondo la quale i dati devono essere organizzati: sempre eguale essa, per quanto varii siano questi: condizione essenziale perché da tutti a proposito di tutte le esperienze particolari una stessa cosa possa essere pensata nello stesso modo. Quello che io osservo per mezzo dei sensi (oggetti di percezione) o che io mi rappresento con l’immaginazione, è «particolare», «contingente», «soggettivo»: il concetto che penso è invece «universale» e «necessario». Vedo o mi rappresento quell’albero, un dato albero (particolare), che c’è, ma avrebbe potuto anche non essere, è così ma avrebbe potuto anche essere altrimenti (contingente), che io, miope, e in queste condizioni di luce e a questa distanza, percepisco in un certo modo, altri in condizioni diverse percepirà in modo diverso (soggettivo). Ma nel concetto io penso l’albero, nella sua universalità, ossia ciò che si deve trovare in tutti gli alberi; e quello che penso io quando ho il concetto di «albero», debbono egualmente pensarlo tutte le menti (necessità razionale) e appunto per questi caratteri del concetto noi possiamo intenderci tra noi [4]».
Distinguiamo almeno il “parere” fondato su argomentazioni convincenti dal capriccioso “io la penso così, dunque è vero quello che penso io”! Anche se, per un relativismo categorico, nessuna argomentazione potrà mai essere più convincente di un’altra. Insomma: se per me l’acqua è vino, essa è vino e basta! E se per te invece è olio, sarà olio e basta! Figuriamoci in che modo riusciremo più a fare la spesa in un contesto “illuminato” da questo tipo di credenza…
La quale tuttavia si può mettere, A PIACERE, in discussione, ritornando a una visione meno cervellotica delle cose.
Diversamente, il Caos.
Amato Maria Bernabei
[1] «Per la scienza esiste la realtà oggettiva, che si raggiunge attraverso la ricerca critica, ma per una società affetta da infodemia esistono solo verità soggettive. Infodemia: che cosa significa questo termine questa nuova malattia della nostra società? È la quantità eccessiva di informazioni generata dalla tecnologia di Internet, che rendono difficile orientarsi su un certo argomento, perché è difficile capire quali sono le fonti affidabili […] Il potere non ama la scienza, perché la scienza è libera. È emblematico il caso di Galileo, ma quanti scienziati sono stati e sono tuttora perseguiti per le loro idee, perseguitati da parte dei regimi autoritari. La tecnologia viene invece asservita ad interessi economici, politici e ideologici» (Maurizio Muraca, Da cosa deriva e cosa implica la perdita di fiducia nella Scienza? TEDxAsiago, consultazione del 25 marzo 2024:
https://www.youtube.com/watch?v=LS7udUns54w)
[2] Alla voce Diritto in Giacomo Devoto, Giancarlo Oli, op. cit.
[3] Ludovico Geymonat, Storia della filosofia, Milano, Garzanti, vol. II, pp. 205-206). Per Kant il Giudizio.
[4] Eustachio Paolo Lamanna, Nuovo sommario di filosofia, Firenze, Le Monnier, 1971, p. 50.